STRUMENTI CULTURALI
del Magazzeno Storico Verbanese
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
- Articolisti:
- [Anonimo], [[T.]]
- Titolo Articolo:
- Memoria sui principali teatri di Milano
- SottoTitolo Articolo:
- Testata ospitante l'articolo:
- La Moda
- Data:
- 1836 gen 01
- Progressivo di Edizione:
- 1836, n. 01 (I) - 1836 gen 01
- Note Generali:
- Breve storia e descrizione
del
Teatro
ALLA SCALA DI MILANO
All’uopo di render sempre più degno del pubblico favore il nostro Giornale e provare che mal si apporrebbe, chi argomentando dal suo nome volesse crederlo sol destinato alle materie meramente piacevoli e leggiere, egli è nostro divisamento di seguitar non solo come abbiam principiato ad arricchirne la parte teatrale, della storia drammatica nostra e dell’altre nazioni ma ben anco a ornarla di quando in quando della descrizione storica e architettonica dei principali teatri dell’Italia anzi dell’Europa in un coi disegni di questi eseguiti sui migliori modelli che ci verranno presentando le memorie dell’Arte. Ora dando subito mano all’esecuzione del detto nostro divisamento ne piace d’incominciare dal Teatro alla Scala sì per la preminenza che si vuol sempre dare alla patria e sì ancora per essere questo senza contraddizione quanto ad ampiezza e magnificenza il primo edifizio che vantino in questo genere i tempi moderni.
Una diligentissima Memoria sui principali teatri di Milano di cui ci fu cortese il sig. Gioacchino Civelli Archivista della Casa Borromeo ci somministrerà le notizie storiche intorno all’edifizio medesimo e dalla Storia e Descrizione de’ principali Teatri antichi e moderni pubblicata pochi anni sono per cura del chiarissimo dottor Giulio Ferrario trarremo quanto si riferisce alla parte architettonica procurando di stringere ogni cosa nel più breve spazio che ci dia dal merito della materia conceduto. Rimasto preda delle fiamme nell’anno 1776 per la seconda volta il Teatro Ducale i proprietari de’ palchi mercè l’interposizione dell’Arciduca Ferdinando gran promotore e fautore d’ogni più bell’edilizio che accrescer potesse i comodi o gli ornamenti di Milano ottennero per decreto 15 luglio 1776 dall’imperatrice Maria Teresa di fabbricare a loro spese, e com’essi dimandavano due nuovi Teatri grande l’uno, e l’altro minore, con tutti iluoghi accessorj che a questa specie di costruzioni si appartengono. Al qual uopo il detto Decreto ordinava che la Regia Camera cedesse al Corpo de’ proprietari de palchi il luogo che chiamavasi la Collegiata della Scala per fabbricarvi il Teatro grande e quello delle Scuole Canobiane pel Teatro minore. Notate queste due principali disposizioni tralasciamo per brevità di accennare le altre che ivi si racchiudeano e che tutte miravano ad agevolare i modi al compiere i due mentovati edifici.
I disegni proposti ed approvati per l’uno e l’altro di essi furono opera dell’architetto Giuseppe Piermarini di Foligno ma non dovendo noi di presente riferire altro che la storia e la descrizione del Teatro alla Scala lascieremo quel della Canobiana per argomento di un altro articolo quando ci faremo a trattar dei Teatri minori. Approvato dunque il disegno pel Teatro Grande si diede tosto principio a porlo in opera quale or lo vediamo con cinque ordini o file di 39 palchi per ciascheduno più però due palchi in proscenio nei quattro primi ordini e tre meno nei primi tre, quivi essendo quello spazio occupato dalla loggia della Corona e dalla porta d’ingresso alla platea. Quanto al sesto ordine superiore ebbe titolo di loggione per non essere diviso in palchi come i cinque altri.
Crediamo che sia estraneo al nostro intendimento che è quello di dare in brevissimi cenni la storia di questa edificazione e non più il riferir qui le varie convenzioni che seguirono fra i Palchettisti per la distribuzione e proprietà dei palchi come pure gli acquisti che fai si dovettero d’alcuni fabbricati intornoper dilatare lo spazio assegnato da prima, che si trovò insufficiente a tanto edificio.
La Memoria del signor Civelli da noi più sopra citata rende conto esattissimo di tutti queste ed altre circostanze e noi non possiamo altro che incoraggiarlo a far di pubblica ragione questo suo lavoro che servirà senza dubbio ad accrescere il numero dei pregevoli documenti che alla storia patria si riferiscono.
Il Teatro alla Scala come portavano le condizioni del contratto cogli Appaltatori che furono i fratelli Fè, e Carlo Nozetti doveva essere terminato pel carnevale dell’anno 1778 ma per quelle opere di ornatura e perfezionamento che non si possono mai calcolare a puntino esso non ebbe il suo compimento altro che per la stagione teatrale d’autunno dello stesso anno e nella sera del 3 agosto venne finalmente aperto alla curiosità del Pubblico colla rappresentazione d’un magnifico spettacolo serio. La grandiosità e il buon gusto dell’edificio corrisposero in ogni parte alla generale aspettazione comeché fosse grandissima e l’architetto Picrmarini ebbe le lodi dei più, miste alle censure e alle invidie dei pochi che mai non mancano anche nelle opere più sublimi dell’industria umana. Giuseppe Levati e Giuseppe Reina dìpinsero le volte, l’esteriore dei palchi e le sale dei ridotti. Donnino Riccardi dipinse con magico pennello i siparii.
Dal conto generale di tutte le spese occorse nell’edificazione dei due Regi Teatri compilato dal Ragioniere Chignoli in data del 20 gennaio 1790 sappiamo che la somma totale di queste spese ammontò a milanesi lire 1.409.912,14.4 Nell’anno 1807 si rinnovarono per la prima volta le pitture nel Teatro alla Scala nelle quali fu data bella occasione di segnalarsi a pennelli di Giovanni Perego, Gaetano Vaccani, Angelo Monticelli, Pasquale Canna, Tommaso Bisi, Giacomo Pellegatta, Giorgio Walz, Giuseppe Cambiagi, e Giuseppe Lavelli, tutti artisti distinti ai quali furono allogate le varie parti di così fatto lavoro. Essendosi poscia nell’anno 1814 demolito il vicin monastero di S Giuseppe si aggiunse un nuovo fabbricato al Teatro mercè il quale venne allungato il palco scenico e furono aggiunte altre parti opportune alla varietà degli spettacoli ed alla maggior loro decorazione. L’architetto di questa appendice al primo grandioso edificio fu l’Ingegnere Giusti E senza tener parola degli altri ornamenti e ristauri che furono fatti negli anni appresso al Teatro Grande ché ognuno può ricordarsene chiuderemo questi brevi cenni storici colla descrizione architettonica che ne diede il celebre Architetto e Pittore scenico Paolo Landriani tratta dall’opera sullodata del dott. Giulio Ferrario.
«Il nostro Teatro della Scala è uno dei più grandi e dei più ben intesi che si trovino sì per la forma come per gli usi a cui è destinato ed ha tutti que comodi che più o meno si desiderano ancora negli altri moderni così che in questa parte può dirsi che non abbia pari. Un’occhiata che si dia alla sua pianta basta per convincersi che dopo dell’allungamento del palco scenico fatto di recente e di altro fabbricato aggiunto è un teatro in tutte le sue parti il più completo. Un grandioso atrio lo precede per discendere dalle carrozze al coperto che mette in un pari vestibolo che dà ingresso alla platea ed alle spaziose scale doppie da due lati per andare ai corridori dei palchi. Vi sono camere di servizio e d’aspetto, un grande ridotto con altre sale unite per scaldarsi ed altro grande vestibolo per la servitù annesso. Un luogo di pasticceria con molte stanze, un caffè, molt’altri luoghi comodi e per officine e per quanto mai possa abbisognare ad un tale Stabilimento. La sua forma è quella di un semicerchio coi lati prolungati in curva restringentisi che si avvicina a quella del Teatro d’Argentina di Roma. La larghezza del suo maggior diametro è braccia 37 di Milano, quella dove si restringe all’imboccatura del proscenio braccia 29 once 8. La lunghezza di tutta la platea braccia 41 once 9, similmente tutta la platea compresa quella del proscenio, braccia 49, once 6. Del proscenio solo da muro a muro, braccia 7, once 3, punti 6.
Larghezza del medesimo da colonna a colonna, braccia 27, once 6, egualmente dove si ristringe verso il palco scenico, braccia 26. Tutta la larghezza del palco scenico, sino alla divisione dell’arco, braccia 40, once 2, punti 7. Tutta la lunghezza del medesimo palco scenico, compreso l’allungamento fatto di recente, braccia 67, once 2, punti 7. Tutta la lunghezza del fabbricato del teatro, braccia 168, once 3. Il proscenio è decorato da due colonne per parte d’ordine corintio con cornice architravata, il cui sporto è due terzi del lor diametro ed è di grossezza braccia 1, once 7. L’altezza delle colonne, braccia 15, once 8, punti 9. Tutta la trabeazione dell’ordine, braccia 2, once 4, punti 7. Altezza totale del proscenio, terminato da grandi mensole in forma d’attico sopra l’ordine, braccia 25, once 1, punti 5, presa sul piano del palco scenico. Altezza di tutto il teatro, dalla platea sino alla volta, braccia 33, once 7, punti 6. È da notarsi che l’altezza della volta diminuisce qualche poco nel venire al proscenio, così la maggiore, presa sulla linea orizzontale della cornice che corona tutto il teatro, è braccia 6, once 6, e braccia 5, once 7, dove è terminata dal proscenio».
T.- A Cura di:
- [Giuseppe Passera]
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
Magazzeno Storico Verbanese
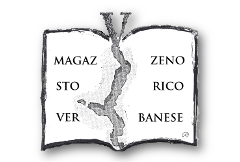 A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.Biografia Carlo Alessandro Pisoni
Carlo Alessandro Pisoni (Luino, 1962 - Varese, 2021). Seguendo le orme del padre Pier Giacomo, dal 1991 al 2017 è stato conservatore, per gentile concessione dei principi Borromeo, dell'Archivio Borromeo dell'Isola Bella. Appassionato studioso e ricercatore, ha sempre voluto mettere a disposizione degli altri conoscenze e scoperte, togliendo la polvere dai fatti che riguardano Lago Maggiore e dintorni; insieme a studiosi e amici, ha riportato alla luce tradizioni, eventi e personaggi passati dal lago, condividendoli con la sua gente.
