STRUMENTI CULTURALI
del Magazzeno Storico Verbanese
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
- Denominazione:
- Lugano (lago), Fiume Tresa, Olona, Pianura Milanese
- Breve Abstract:
- Primo Abbozzo d’un progetto di canale per servire al dissodamento delle brughiere poste nella parte occidentale della Provincia di Milano - Dell’ingegnere C. Possenti (1840)
- Abstract:
Primo Abbozzo
d’un progetto di canale
per servire
al dissodamento delle brughiere
poste nella parte occidentale della provincia di milano
Dell’ingegnere
C. Possenti
Memoria estratta dal 3.° volume del
POLITECNICO di Milano.
Milano, Tipografia Pirola
1840
L`agricultura è la fonte principale della ricchezza della Lombardia, e l`irrigazione è uno dei principali sussidj dell’agricultura lombarda; quindi con buon senno i ricchi proprietarj di fondi, e tutte le amministrazioni che da sette secoli ressero questa bella parte d`Italia, diedero mano ad accrescere con opere più o meno vaste il numero dei canali d’irrigazione e la. copia delle acque loro. È naturale pertanto che, già fin da quando si eseguirono le prime grandiose derivazioni della Muzza e dei Navigli, si fosse vagheggiato il progetto di portare il beneficio dell’irrigazione a quell’estesa ed in gran parte incolta zona della provincia di Milano, ch`è racchiusa a levante dall`Olona, a mezzodì dalla via postale Novarese, a ponente dal Ticino, ed a tramontana dai colli che accennano a Varese ed al lago Maggiore; zona che comprende più di 600 mila pertiche milanesi di pianura non irrigua (circa 40 mila ettari o tornature).
Risulta infatti, dalle due raccolte istoriche dei progetti e delle opere per la navigazione e l`irrigazione del Milanese dell’ing. Giuseppe Bruschetti, che in diversi tempi, daj secoli XIII fino al presente, si diede opera alla compilazione di molti progetti per ottenere il fine suddivisato; e quasi tutti questi progetti si ridussero a derivazioni d’un corpo d`acqua dal Ticino, o dal lago Maggiore, o dal lago di Lugano. Di recente però (nel 1818) l`Istituto italiano di Scienze, Lettere ed Arti propose d`ottener l`irrigazione di parte delle brughiere fra l’Olona ed il Ticino, col trar partito dalle acque che in tempo di pioggia defluiscono dalle vicine alture in vari torrentelli, come l’Arno, la Strona ed altri minori, conservandone le acque di piena in opportuni bacini o laghetti, e distribuendole poscia con regolarità ed economia nei tempi del bisogno.
Ma né il Ticino né il lago Maggiore possono, per ragione di livello, servire allo scopo, e, se il cavo del Pan-perduto fu aperto a tal fine, l’opera appunto per tal causa fallì. Il progetto dell’I.R. Istituto non si trovò poi sufficiente al bisogno, come chiaramente appare dal rapporto della Direzione generale d’acque e strade, sottoscritto dall’ing. Carlo Parea, in data 20 marzo 1819.[1]
La derivazione d’un canale dal lago di Lugano è il solo progetto plausibile, si per ragione di livello, sì per la quantità d`acqua, di cui potrebbesi disporre, e questo è pur quello che si propose nel suddetto rapporto dalr ingegnere Parea. Per il che l’I.R. Direzione con sua lettera 29 settembre 1819, incaricò l`ing. Fumagalli a procedere ad una visita da Ponte-Tresa alle brughiere, costeggiando prima la Tresa, indi i monti del lago Maggiore, fino a guadagnare le alture a cui volevansi condurre le acque, e a stendere un ragionato rapporto, corredato de` rilievi e tipi opportuni, sulla possibilità e sui mezzi più convenevoli per tradurre dal lago di Lugano e propriamente dal fiume Tresa, suo emissario, un corpo acqua d`once 200 milanesi ad irrigar la vasta superficie di brughiere, che si estendono da Golasecca a Castano sulla destra dell’Olona; rapporto, che l’ing. Fumagalli presentava il 31 dicembre del detto anno.
Dalle ispezioni e dai rilievi dell’egregio autore di quel rapporto emergerebbe che la linea più convenevole a seguirsi col canale sarebbe quella, la quale costeggiasse le falde dei monti situati a sinistra del fiume Tresa fino a Germignaga, ove il fiume mette foce nel lago Maggiore; volgesse quindi verso mezzodì, costeggiando i monti del lago stesso all’altezza media di 72 metri sul suo pelo basso, e seguendo le numerose sinuosità delle foci de` suoi influenti; giunta poscia a Laveno, abbandonasse il lago, rivolgendosi fra levante e mezzodì, parallelamente alla strada Varesina; e finalmente, seguendo le rive occidentali dei laghi di Varese e di Comabbio, venisse a sboccare sul più elevato piano della brughiera di Golasecca sotto Sesona, d`onde poi il canale avesse a procedere senza veruna difficoltà attraverso alle brughiere da irrigarsi.
L’autore di quel gigantesco progetto enumera le gravi difficoltà da superarsi in causa delle alte catene dei monti e delle ampie e profondissime valli, fra cui il canale avrebbe a passare, percorrendo fra Ponte Tresa ed il piano più alto delle brughiere il lungo sviluppo di 62 mila metri con una sezione di 9 metri di larghezza, e metri 2 ¼ d`altezza viva d’acqua, e colla pendenza 1/4000. Questo grandioso canale dovrebbe, per undici mila metri almeno, essere scavato nella viva roccia, e nel resto bensì in terra, ma a considerevoli profondità. I principali edificj, che dovrébbonsi costruire, sarebbero: un acquedutto lungo metri 600 ed alto metri 65 sul piano della Val-Travaglia, opera che sarebbe forse unica nel suo genere; un altro sulla valle del Bardello, lungo 150 metri ed alto 22; la chiusa di derivazione dalla Tresa; sei ponti-canali sopra grossi torrenti; altri 30 sopra torrenti minori; molti ponti per communicazione delle strade intersecate, e finalmente le armature in muro delle sponde, per due terzi almeno della lunghezza del canale.
L’enumerazione delle tante e sì gravi difficoltà da superarsi viene accompagnata dal dotto autore del progetto con alcune riflessioni, da cui palesemente traspare opinarsi da esso l’inconvenienza dell`esecuzione per ciò che riguarda la parte economica. Del che è facile convincersi, se si considera che, quand’anco assicurar si potesse la derivazione, non di sole 200 once, ma di 300, com’è probabile, non potrebbe esservi convenienza nell`esecuzione del progetto, se il dispendio dovesse esser maggiore di otto milioni di lire; somma senza dubbio inferiore a quella del presumibile importo di tutte le opere che sarebbero da eseguirsi.[2]
Leggendo quell’interessante rapporto, con sott’occhio la magnifica carta .topografica della Lombardia dell`istituto geografico militare, fra me e me ragionava: poiché dal pelo del lago di Lugano al piano delle alte brughiere di Golasecca vi ha meno di 20 metri di pendenza totale, e dalla punta più meridionale del detto lago presso Porto-Morcote al piano suddetto si hanno soli 25mila metri di distanza rettilinea, non potrebbe egli essere più conveniente, invece di far girare il canale per tante circonvoluzioni dello sviluppo di 62mila metri, perdendo così molto di velocità, e vincolandosi quindi anco a dare al cavo una sezione molto maggiore, l’andar dritto dritto al fine, coll’estrarre le acque del lago a Porto-Morcote, e con un cavo rettilineo portarsi direttamente a Sesona? Ma l’esecuzione d’un tal progetto esigerebbe che il cavo scorresse entro galleria sotterranea lunga forse ventimila metri, la cui costruzione sarebbe impossibile, se non si potesse sostituire ai consueti finestroni laterali, qui affatto ineseguibili, una serie di pozzi, situati a convenevoli distanze; da ciascuno de` quali si venisse mano mano estraendo la materia, scavata dalle due metà prossimiori di due tronchi contigui di galleria.
A questo pensiero opponevasi tosto la difficoltà, che, andandosi direttamente da Porto-Morcote a Sesona, si sottopasserebbero colla galleria parecchi monti; cosicché i pozzi ideati potrebbero riescir profondi i 400 e i 500 metri; circostanza, che, qualora fosse inevitabile, renderebbe assurdo ogni ulteriore esame in proposito. Laonde mi proposi in primo luogo d’investigare, se fra i monti che attorniano il lago di Lugano, in vicinanza di Porto-Morcote, non si aprisse qualche varco bastevolmente depresso, pel quale di valle in valle potesse condursi la galleria sotterranea a poca profondità sotto le valli, e così diminuirsi talmente l’altezza dei pozzi da rendersi trattabile la convenienza del progetto.
Osservai quindi la seconda delle livellazioni, eseguite per cura della Direzione Generale d’acque e strade nell’anno 1817, livellazione, che ha principio al pelo basso del lago di Lugano a Porto-Morcote, ascende per la Val-Poaggia, discende la Val-Bévera, ora Cavo-Diotti, sboccante nell’Olona poco disopra al ponte di Malnate, sotto la via postale fra Varese e Como; continua a discendere lungo Olona e termina alla platea inferiore del mulino di Gurone; e perciò viene a percorrere metri 17421, seguendo sempre il fondo più depresso delle valli, ascendendo lungo una linea di .metri 4840 all’altezza di metri 63,50, e discendendo per mia linea di metri 12581 a una profondità di metri 72,56, in modo di riescire all`ultimo punto della livellazione metri 9,06 sotto il pelo basso del lago.[3]
Mi formai quindi un profilo di questa livellazione, sul quale segnai il presumibile andamento della galleria colla pendenza d’1/2000 e vidi, che la profondità media dei pozzi non giungerebbe ai 40 metri; profondità che mi animò a continuare le mie osservazioni.
Dietro alcune di tali osservazioni porterei quindi opinione, che la galleria sotterranea seguisse sempre l’andamento della sopradetta livellazione fino a quel punto che si trovasse più conveniente per far rivolgere la galleria verso le brughiere nella direzione di ponente, o di ponente mezzodì. La scelta del luogo della deviazione dovrebbe dipendere dalla combinazione dei tre elementi di spesa: la lunghezza della galleria, cioè, la profondità dei pozzi, e la natura della materia da escavarsi. Né sarebbe improbabile di rinvenire, fra il punto di confluenza della Bévera nell’Olona e l`origine del torrente Strona, una o più vallette, lungo le quali potesse il cavo scorrere, o totalmente scoperto, od in parte scoperto e in parte no, ma sempre con molta probabilità d’una tenue profondità di pozzi. Giunto poi che il cavo fosse nelle vicinanze di Crugnola, dovrebbe ripiegare verso mezzodì, in forma di cavo commune di pianura, seguendo prossimamente la linea del confine doganale verso il Ticino, la quale separa per il lungo quasi in due parti eguali l’ampia superficie di brughiere e di terreni asciutti che si dovrebbero irrigare. Così il cavo riescirebbe costituito da tre tronchi. Il primo ed il più importante de` quali sarebbe il sotterraneo dal lago all’Olona; e potrebbe riescire lungo dai 15 ai 20 mila metri, a norma del diverso punto d`onde devierebbesi alle brughiere. Il secondo scorrerebbe in parte scoperto ed in parte no, secondo l`andamento de` terreni interposti all’Olona ed alla Strona, e riescirebbe lungo dagli 8 ai 10mila metri, circa, e opporrebbe bensì difficoltà molto minori del primo, ma pur sempre importanti. Il terzo, dal quale dovrebbero farsi le estrazioni dei cavi irrigatorj, non offrirebbe la menoma difficoltà; e non potrebbe riescire se non di lieve spesa, in confronto ai primi tronchi, sebbene della notabile lunghezza di 20 mila e più metri.
Prima però di ragionare del cavo-galleria, terrò discorso della quantità d`acqua, di cui presumibilmente potrebbesi disporre. Dal dotto rapporto dell’ing. Fumagalli rilevasi, che, giusta le informazioni da lui assunte a Ponte-Tresa, l’emissario del lago di Lugano, in tempo di magra, ha una sezione larga metri 40, alta metri 0,50, con 1/1800 circa di pendenza. Ciò, secondo l’autore, corrisponderebbe alla portata di 700 m.cub per ogni minuto primo, ossia a 330 once milanesi, ritenuta l`oncia di 2,12 per 1’ ossia di 0,03533 per 1”. Applicando però questi dati alle tavole della velocità media, calcolate colla formola idrometrica di Eytelwein, e publicate nel fascicolo delle Ricerche geometriche ed idrometriche della scuola degli ingegneri pontifici nell’anno 1821 (Milano, tipografia Giusti), trovo che la portata del fiume Tresa sarebbe di m. cub. 16,6 per 1", ossia d`once milanesi 470. Potrebbe però darsi che nel caso presente la formola d`Eytelwein non fosse rigorosamente applicabile, colla speranza di risultati molto prossimi ai veri, per la ragione che il moto nel primo tronco d’un emissario non è per anco reso uniforme, siccome già ebbi a notare nella mia Memoria sulla Sistemazione dell’emissario del lago di Como;[4] per cui la portata delle 470 once, desunta dalla suddetta formula, in questo caso potrebbe riescire alquanto maggiore del vero.
Ritenendosi dall’ing. Fumagalli, che in acque basse la presa scarichi soltanto 330 once d`acqua, egli ne desume potersi con sicurezza ammettere che non sarebbero mai per mancare al canale derivato dalla Tresa le 200 once proposte derivarsi dall’I.R. Direzione d’acque e strade; e anzi non sarebbe nemmeno per mancare la quantità necessaria a lasciarsi nel fiume, per animarvi i dieci mulini stabiliti lungo il suo corso. Nel caso però che avvenisse tale siccità da non potersene derivare le proposte 200 once, il sig. Fumagalli saviamente suggerisce d`assoggettare il lago ad un abbassamento artificiale in tempo di magra, estraendo dal suo bacino la quantità che mancherebbe ai suoi influenti, per raggiungere le 200 once. Il che si otterrebbe col tener la chiusa di derivazione a tale altezza, da trattenere, anche in massima magra, nel lago le acque ad un livello conveniente, e col situar similmente la soglia della bocca di derivazione a tale profondità sotto la cresta della chiusa, che bastasse a scaricare dalla bocca l’acqua del lago stesso per tutta quell’altezza, che si troverebbe necessaria.[5]
lo però tengo per fermo che non già sole 200 once, ma bensì 400, e anco di più, assicurar si potrebbero al canale progettato, non però durante tutto l’anno, ma duranti i 110 giorni della più necessaria irrigazione estiva, cioè dal 12 di maggio alla fine d’agosto; oltre di che se ne potrebbero assicurar 200 dal 12 d’aprile al 12 di maggio, e 150 pel resto dell’anno.
Ma contro siffatta asserzione sento elevarsi tosto la difficoltà, che una tale derivazione nocerebbe indubbiamente a quella del Naviglio Grande, sottraendo al lago Maggiore la più gran parte delle acque d`un suo primario influente, quale è la Tresa, sapendosi pure essere molte volte avvenuto, specialmente in questi ultimi anni, di dover chiudere totalmente la così detta bocca di Pavia, per dar la dovuta competenza al Naviglio stesso. Agevole però è il mezzo di superare una tale difficoltà; e questo mezzo consiste nell’attraversare l’àlveo della Tresa con un edificio regolatore, cioè con una chiusa a paraporti; con cui si possano trattenere nel lago le acque di piena, che ora si scaricano a pura perdita nel Ticino, per poterle utilizzare con un regolare riparto fra la Tresa ed il nuovo canale, in tempo di scarse acque. Ed in fatti 200 once d’acqua per 30 giorni, dal 12 aprile al 12 maggio, e 400 once per 110 giorni, dal 12 maggio al 3o agosto, equivalgono, in ragione di 2,1 m.cub. per ogni minuto primo, a 152640000 m.cub. E, ritenuta la superficie del lago di Lugano, a pelo ordinario, di 50 milioni di m.q,[6] l’altezza d’acqua del lago, che basterebbe a somministrare le dette quantità d’acqua, sarebbe di metri 3,053.
Ora i varj livelli del pelo del lago ne` suoi diversi stati risultano dalle notizie statistiche annesse alla citata carta topografica della Lombardia, superiori al pelo di massima magra, come segue:[7]
Pelo di magra ordinaria metri 0,10
Detto ordinario o mezzano metri 1,10
Detto di piena ordinaria metri 1,85
Detto di massima piena metri 3,21
cosicché la sola differenza de` peli di magra ordinaria e di piena ordinaria ammonta a metri 1,75. Ora ogni anno sogliono accadere due avvicendamenti di questi stati ordinali. Avviene il primo al sopravenir delle piene di primavera, dopo le solite magre d`inverno, ed il secondo al sopravenir delle piene autunnali, dopo le magre d`agosto e settembre. Entra quindi ogni anno nel lago la quantità sufficiente ad alimentare il canale, senza defraudar la Tresa dell’acqua che le perverrebbe in magra ordinaria, acqua che ammonta, come si disse, a 470 once circa, o poco meno.
Fo notare altronde che la magra massima del Ticino, che può costringere a chiuder la bocca di Pavia, non potrà mai in ogni caso continuare oltre il 22 maggio, prima del qual tempo sopraggiungono sempre le piene ordinarie del Ticino. Perloché potrebbesi, senza il più piccolo pregiudizio, verso il 22 maggio, non lasciar più definire nella Tresa fuorché la tenue quantità necessaria pel movimento de` suoi mulini, accordando la maggior parte dell’acqua influente nel lago al nuovo canale. In tal modo la porzione d’acqua, che dovrebbesi trattenere nel lago a servigio del canale, consisterebbe nelle sole 200 once, che vi si lascerebbero definire dal 12 aprile al 12 maggio, e nelle 400 once che vi si somministrerebbero dal 12 al 22 maggio le quali ammontano a soli metri 0,61 d’altezza d’acqua del lago. Il che mi persuade che, col mezzo della chiusa regolatrice del lago di Lugano, si potrebbe non solo mantenere al canale la detta quantità d’acqua, ma in oltre somministrare alla Tresa, dal 12 aprile al 12 maggio, una copia d`acqua maggiore di quella, che al presente le somministri il lago in tempo di massima magra, e ciò a vantaggio particolare del Naviglio Grande, e delle inferiori derivazioni del Ticino, il Naviglio Langosco cioè, e la Roggia Sforzesca.[8]
In tal modo con 400 once estive d’acqua si potrebbero mantenere 200000 pertiche di prati irrigatorj, parte alla destra e parte alla sinistra del canale percorrente le brughiere, valutando che con ogni oncia d’acqua si possano irrigare 500 pertiche di prato. Ciò ben s`intende nel supposto che si esauriscano tutte le colature; il che sarebbe agevole in questo caso, attesa la regolare pendenza generale delle brughiere, e che sia già scorso l’intervallo di tempo necessario a stabilire la cutica dei prati, mentre prima di ciò, attesa la natura incoerente di quel terreno non se ne potrebbe mantenere irrigatoria più della metà. Sarebbe così il canale costeggiato per 20000 metri da due liste di prato, della larghezza ciascuna di metri 3272; coi prodotti delle quali potrebbonsi ridurre a coltivazione di grani, gelsi e viti tutti gli altri terreni inculti fino all`Olona ed al Ticino.
Né gli abitanti del litorale del lago, sì svizzeri che lombardi, avrebbero menomamente a temere che la chiusa regolatrice potesse talora esser causa d’inondazioni per piene sovragiungenti. Che anzi la medesima gioverebbe a mantenere il lago ad un pelo quasi costante in tempo di piena anche straordinaria. La qual verità può dimostrarsi nei modi stessi, coi quali provai che simili effetti produrrebbe la chiusa regolatrice, da me proposta allo sbocco dello stretto d’Olginate sull’Adda, pel solo fine appunto di mantener alte le magre, e basse le piene del lago di Como. Egli è chiaro però, che, per ottener così importante vantaggio, diventa necessario abbassare il fondo della Tresa nel suo tronco superiore, ponendo le soglie de` paraporti al dissotto un metro o più del livello più elevato dell`attual fondo dell`incile; colle quali cautele si potranno contenere le massime piene più depresse d`un metro delle attuali.
Il lago di Lugano poi ed il suo emissario trovansi, per questo riguardo in posizione assai più vantaggiosa de laghi Verbano e Lario e dei loro emissarj. La Tresa infatti, due miglia dissotto al suo incile, fa salti considerevoli, che permettono di dare al fiume tutto lo sfogo desiderabile con minore spesa, che non sul Ticino e sull`Adda. Il lago di Lugano poi ha una superficie, in confronto della superficie de` rispettivi dominj fisici, assai maggiore degli altri due laghi. Infatti il dominio fisico del lago di Lugano, misurato sulla gran carta dell`Istituto geografico, è di 470 milioni di m..q.; quindi la superficie del lago sta a quella del suo dominio fisico come 5:47, ossia come 1:9 1/3; Le superficie invece del lago Maggiore e di quello di Como sono rispettivamente di miglia geografiche quadrate 58,90 e 45,70, mentre quelle de`loro dominj fisici sono di miglia geografiche quadrate 3050 e 1631. Quindi i rapporti delle superficie de` laghi a quelle de` loro dominj fisici sarebbero pel lago Maggiore circa come 1:52, e pel lago di Corno circa come 1:36. Questa circostanza, aggiunta a quella del libero sbocco nella Tresa, fa sì che le piene non possano né molto elevare le acque del lago di Lugano, né far succedere grandi incrementi d`altezza in breve tempo; cosicché riescirebbe assai più facile di regolare coll`opera de` paraporti il pelo del lago stesso in tempo di piena.[9]
Passando ora ad altro importante argomento, cioè a quello delle dimensioni da darsi alla sezione della galleria, pare che si avrebbero a sceglier quelle, che, a sezione e pendenza data, somministrassero la massima portata. Le quali dimensioni, pel caso della sezione rettangolare, sono quelle della larghezza doppia dell’altezza. E poiché la portata ordinaria del canale dovrebbe essere di 400 once, ossia di 14 m. cub. per 1", sarà necessario che il canale sia capace almeno di 20 m. cub., tanto per provedere all`aumento d`acqua, che potrebbe in esso decadere per qualsiasi causa, quanto per impedire che ogni probabile aumento elevasse il pelo fino alla sommità della galleria. Quindi è che nel nostro caso potrebbesi ritenere la galleria un rettangolo largo met. 5,5, ed alto met. 2,75. Applicando infatti alle Tavole idrometriche, desunte dalla formola d`Eytelwein, queste dimensioni, e ritenuta di 1/2000 la pendenza del canale, la sua velocità media si troverebbe di 1,337m / 1". Perloché la portata riescirebbe di 222 m. cub. per 1", la quale, in ragione di met. c. 2,12 per ogni oncia milanese d`acqua, sarebbe d`once 573. E perciò le assunte dimensioni sarebbero più che sufficienti allo scopo, né l`altezza viva dell`acqua potrebbe mai raggiungere la sommità della galleria.[10]
Ma se da un lato le suddette ditnensionì avrebbero il vantaggio di corrispondere alla sezione minima, e quindi anco alla minima escavazione per una portata data, dall’altro non corrisponderebbero alla minima spesa. Infatti egli è evidente che la galleria "dovrebbe essere in parte naturale, ed in parte artificiale. Sarebbe naturale ovunque la materia da scavarsi fosse roccia o pietra più o meno dura, ma tale da non corrodersi pel rapido passaggio del-l’acqua del canale, né da alterarsi per effetto delle filtrazioni dell’acqua superiore; le quali potrebbero essere moltissime in alcuni tempi e luoghi. Sarebbe invece artificiale, ossia a pareti e vòlta murate, ove si verificasse il caso opposto, cioè dovunque la galleria dovesse escavarsi in terra, ghiaja, sabbia, od altra materia più o meno incoerente, o di consistenza non bastevole a sostenersi contro le combinate azioni dell’acqua del canale e della filtrante.
Or nella costruzione della galleria naturale devesi far uso principalmente delle mine, e la comoda e vantaggiosa posizione de` minatori è uno de` principali elementi d’economia in questo genere di costruzione; il qual elemento mancherebbe del tutto colle dimensioni sopra calcolate. Infatti l’altezza di metri 2,75 è sommamente svantaggiosa dal lato economico; poiché, per avere il maggior utile nell’escavazione delle rocce delle gallerie è d’uopo scavare con qualche stento, ed a forza di piccole mine, uno strato superiore di metri 1,70 circa, per lasciar libero dalle due bande, superiore ed anteriore, un grosso strato inferiore, che allora rendesi atto ad essere attaccato con mine grosse e profonde. Questo metodo è di molto maggior effetto utile, per la ragione che i pezzi attaccati dalle mine, trovandosi più isolati, trovano anche assai minor resistenza al distacco, che non quando sono stretti fra rocce tutt` all’ingiro. Una tal circostanza influisce tanto sulla spesa, che la stessa roccia, la quale fuori dalle gallerie, e perciò libera da due parti, si escava ed abbatte con una spesa di lire 3 per ogni metro cubico, nell`interno di gallerie, benché sufficientemente ampie, non escavasi se non jr doppio prezzo, cioè da lire 9,50 a 10,25 al metro cubico.[11] Né consegue quindi, che pel lato economico l`altezza dovrebbe tenersi la maggiore possibile, affinché lo strato inferiore, che viene isolato da due parti, riesca il più possibilmente alto. Quanto al determinare la larghezza è duopo considerare che ogni coppia di minatori, l’uno che tiene lo stampo perforatore,[12] l’altro che lo batte a colpi di mazza, occupa la larghezza di circa metri 1,40. Quindi per la più utile disposizione dei minatori occorrerebbe che la larghezza fosse multipla di 1,40. In conseguenza di che pare, che le più convenienti dimensioni esser potrebbero di metri 4,20 per la larghezza e di metri 4 per l’altezza, ritenuto che la sezione delle gallerie non è un semplice rettangolo, ma un rettangolo terminato da un semicerchio, o da qualche altra linea curva. Con tali dimensioni infatto, supposto che il pelo d`acqua abbia un metro di franco, ossia rimanga un metro più basso della sommità della viSlta, la portata del canale sarebbe di 1810.,56 per t", ossia di 525 once milanesi d’acqua, ciò che sarebbe sufficiente al bisogno.
Venendo a discorrere de` tronchi di galleria artificiale, parrebbe a prima vista che le proporzioni del minimo perimetro dovessero essere le pià utili, tanto per la minor escavazione di materia, quanto per la minor quantità di muratura occorrente; ma anco per questi la facilità di costruzione deve preferirsi al minor volume delle opere. Ora è indubitato che la costruzione delle pareti e della vòlta riescirebbe di costo molto minore, a pari volume, con pareti verticali più alte, e vòlta di minor ampiezza; e perciò vi sarà una proporzione fra r altezza e la larghezza da darsi alla galleria artificiale, la quale corrisponderà alla minima spesa. Questa proporzione potrà variare da un tronco all’altro, s.econdo la qualità della materia da scavarsi, e della maggiore o minor distanza, da oui si avranno a prendere i materiali per la muratura.
Uno degli importanti elementi di spesa sarebbe la distanza de` pozzi; infatti, quanto più la stessa fosse piccola, tanto minore riescirebbe la spesa del trasporto orizontale della materia sì fuori che dentro della galleria, oltreché sarebbe utilissimo l’aumento di luce, che produrrebbe la moltiplicità de` pozzi. Né per queste sole ragioni converrebbe che i pozzi fossero situati a piccole distanze. Avvi un`altra circostanza, che cangia la convenienza in necessità, ed è la libera circolazione dell’aria; la quale è indispensabile, perché possano presto dissiparsi i gas mefitici, che, misti al vapor acqueo, si sviluppano dall’esplosione delle mine, e che, senza una copiosa circolazione d’aria non potrebbero se non in lungo intervallo di tempo abbandonare il luogo delr esplosione, con grave aumento di spesa di lavoro, in causa del tempo, che perder dovrebbero i minatori prima di rimettersi all’opera, dopo l`esplosione delle mine.
Ma d’altra parte la moltiplicità dei pozzi importa una maggiore spesa d’escavazione e di costruzione dei pozzi stessi. Laonde si presenta tosto una facile questione di massimi e minimi, per determinare qual esser debba la distanza de` pozzi, e quindi il loro numero totale, perché sia minima la spesa, avuto riguardo in complesso all`aumento dell’escavazione ed alla diminuzione delle spese di trasporto. Intavolata e sciolta ch`ebbi una tal questione, applicai alle quantità algebriche, costituenti la relativa formola, de` valori numerici, che ritenni così all’ingrosso per verisimili; e mi risultò che la distanza fra due pozzi successivi dovrebbe essere di 130 metri circa. Ma considerate le particolari circostanze del bisogno di luce e d’aria circolante, potrebbesi ritenere la suddetta distanza di soli metri 100.
Quanto al diametro dei pozzi parrebbe sufficiente il limitarlo ad un metro e mezzo.
Fra i monti, che s` inalzano fra Porto-Morcote e Varese, sotto i quali dovrebbe correre la galleria, avvi quello in cui si trovano le cave della nzolera di Viggiù, pietra facile a perforarsi; perloché si può presumere che la galleria naturale non sarebbe per importare una spesa sproporzionata all’utile, che deriverebbe dalla condotta d`acqua. Laddove poi la galleria dovrebbe essere rivestita di muro, la spesa di escavazione sarebbe tenue, attesa la natura della materia, che potrebbe scavarsi col solo uso del zappone. Ma rilevanti però sarebbero per riescire le spese dà costruzione de` muri e della vòlta, tanto per la qualità idraulica del cemento da usarsi, quanto per le difficoltà, che offrir potrebbe in alcuni luoghi, ove la materia da scavarsi avesse poca coerenza, la contemporaneità delle due operazioni di scavar terra e costruir pareti e vòlta per impedire gli scoscendimenti delle materie. Ad onta di tutto ciò non crederei che la galleria artificiale potesse importare una spesa maggiore della naturale.[13]
La costruzione della galleria e del successivo canale aperto, per ciò che riguarda le numerose filtrazioni, che, in essa decorrendo, difficolterebbero i lavori, potrà farsi in due modi, cioè: 1) col dar principio alle operazioni nella parte inferiore del canale, e procedere mano mano all’insù fino alla bocca di derivazione; 2) col distribuire i lavori contemporaneamente lungo tutta la linea, ad eccezione soltanto d’una tratta di 1000, o 1500 metri verso l’origine. Il primo modo avrebbe il vantaggio di lasciar all’acqua filtrante un libero corso all’ingiù, per cui gli operaj non sarebbero incomodati dalle acque, che diversamente si arresterebbero sul fondo di ciascun tronco con nocumento dei lavoratori, e quindi sarebbe necessario estrarle artificialmente con aumento di spesa. Ma quel modo avrebbe due inconvenienti, cioè, che le opere non potrebbero eseguirsi fuorché in lunghissimo corso di tempo, non potendovisi impiegare più di otto o dieci lavoratori contemporaneamente; e la materia d’escavazione di ciascun tronco di galleria dovrebbesi esportare tutta quanta dal solo pozzo situato all`estremo inferiore del tronco, con aumento di spesa di trasporto.
Il secondo modo invece eviterebbe i due inconvenienti del primo, ma costringerebbe ad estrarre artificialmente dai pozzi col mezzo di opportune trombe o d’altre machine idrovore tutta l’acqua di filtrazione. Perché poi le trombe potessero far utilmente il loro officio, senza pregiudizio de` lavoratori posti inferiormente al pozzo, sarebbe necessario, che il fondo della metà superiore di ciascun tronco di galleria si stabilisse con pendenza ascendente, in modo che le acque filtranti nella metà inferiore d’un tronco e nella metà superiore del successivo venissero a colar tutte immediatamente sotto il pozzo intermedio a tali metà di tronco. Terminata poi la costruzione della galleria, avrebbonsi a levare tutti i piani inclinati lasciati in tal modo sul fondo delle metà superiori d`ogni tronco.
Posti a confronto gli utili e i danni de` due modi di costruzione sopra descritti, non dubiterei punto a dar la preferenza al secondo. Perché poi le filtrazioni non abbiano a danneggiare i muri e la volta dei tronchi di galleria artificiale, importa che questi siano muniti d’una serie d’opportuni e frequenti sfori, che permettano il libero deflusso delle filtrazioni nel canale.
Venendo ora al trasporto della materia scavata, è agevole il vedere che la medesima si farebbe percorrere tanto l’interno della galleria, quanto l’interno de` pozzi col sussidio di semplici machine, situate alle bocche de` pozzi, e mosse dagli uomini o dai cavalli. Ed in molti luoghi sarebbe facile usar per motore l’acqua delle valli, condotta con canaletti di legno, a dar moto a semplici ruote idrauliche di poca spesa, di che trovasi frequentissimi esempi nelle valli montane e nei lavori delle miniere.
È fuor di dubbio che molte e gravi difficoltà si potrebbero incontrare nell`esecuzione di quest`opera, fra le quali le più probabili sarebbero quelle che procedono dalle numerose sorgenti e filtrazioni e dall’incontro d’ampi antri cavernosi, da doversi superare con qualche edificio di canale od altro. Ma queste non sono difficoltà da non potersi superare per la parte tecnica, e quanto alla parte economica, non crederei che possano riescir tali da rendere inconveniente l`esecuzione del progetto. E chi sa anco, che l’incontro di tali difficoltà non possa essere accompagnato da qualche compenso? Non potrebbe forse l’abbondanza delle sorgenti supplire ad una parte delle acque del lago? e l’incontro d`antri cavernosi diminuire le spese di trasporto della materia d’escavazione?
Oltre la chiusa regolatrice da situarsi all’imboccatura del fiume Tresa, sarebbe a costruirsi un edificio, o bocca di derivazione, con un sistema di paratoje, per regolare la derivazione medesima. Appena poi il letto del nuovo canale si trovasse a tal livello da potervi comodamente praticare uno scaricatore, sarà necessario il praticarvelo tosto, e ben ampio, a tutela dell’inferior tratta di cavo e dei fondi laterali, gíacché, ad onta d’una ben regolata derivazione, le sue acque potrebbero venir di molto ingrossate dalle filtrazioni. L’Olona, l`Arno, la Strona, il Ticino e il Naviglio potrebbero giovare ottimamente a ricevere le acque di piena e le residue.[14]
La prima delle opere da eseguirsi dovrebbe consistere nell’escavazione e costruzione di tutti i pozzi. Le ragioni di ciò sono molte ed evidenti, e fra queste non ultima sarebbe la circostanza, che, rimanendo in tal modo ben determinato quali e di quanta lunghezza riescir possano i tronchi in galleria sì naturale che artificiale, si potranno dare con tutta facilità le opportune disposizioni, relative alle singole circostanze; e si potrà anche lasciare nell’interno delle gallerie naturali, e nelle località convenienti, quella quantità di sassi e di pietre che si troverà necessaria per la muratura dei tronchi di galleria artificiale, non esportandosi fuorché l’esuberante.
Siccome poi lungo le brughiere, in cui dovrà scorrere il canale aperto, vi hanno 50 e più metri di pendenza, la quale può godersi ad uso d’opifici idraulici, e che dovrebbe necessariamente levarsi all`andamento generale del cavo, per ridurla ad 1/400, o poco più, col mezzo d’un sistema d`apposite levate, così è evidente che sul cavo stesso potrannosi stabilire molti opifici, fra i quali potrebbero aver posto quelli che avessero bisogno di disporre di forze di 100 e 200 cavalli.
Sono persuaso che tali idee saranno giudicate da alcuni come inverosimili, e da molti come assai arrischiate, ed io stesso confesso di portare quest`ultima opinione. Ma non sarebbe nemmeno improbabile che, col solo rimettersi in campo un`utile idea, posta da canto già da molto tempo, potesse ora questa, coll`opera di menti più sagaci della mia, diventar fonte di notevole beneficio al nostro bel paese, ciò ch`è il primo e più costante de` miei desideri.
[1] Storia de` progetti e delle opere per l`irrigazione del Milanese, di Giuseppe Bruschetti, pag. 338.
[2] Questa asserzione si riferisce al solo caso che l’opera venisse assunta dal governo, poi quale sarebbe conveniente, quand’anco il reddito mediato de` capitali, che v`impiegasse, fosse al dissotto del 3 p. o/o, a causa di tutti i vantaggi mediati che ne trarrebbe. Ad una società privata la speculazione non sarebbe utile, se l`acqua venisse a costare più di ventimila lire all`oncia, in causa specialmente della difficoltà d`utilizzarla nei primi anni sopra terreni inculti, che i proprietarj non potrebbero dissodare se non col mezzo d’altri rilevanti capitali, oltre la spesa dell`acqua.
[3] Vedi la citata Istoria dei Progetti, ove (pag. 333) si descrive quella livellazione. Nell`ultima delle altezze è però Incorso un errore forse di stampa, poiché la platea inferiore del mulino di Gurone è met. 9,06 al disotto del pelo basso del lago e non al di sopra, come trovasi nell`opera -del Bruschetti; ciò che agevolmente si riconosce dal confronto colla livellazione del fondo dell’Olona, riportata a pag. 453 della stessa opera; nella quale .vedesi, che, dal .fondo Olona sotto il ponte di Mutuate alla platea inferiore del mulino di Gurone, vi ha una totale. pendenza di metri 30,665, invece di met. 12,54; la quale differisce dalla precedente di met. 18,125, cioè del doppio de` metri. 9,06 circa.
[4] Milano, presso Angelo Monti 1839.
[5] A. pag. 331 (Nota) della raccolta di Bruschetti, ove si dà ragguaglio della prima delle tre livellazioni, rilevate nel 1817 per cura degli Ingegneri della Direzione d`acque e strade, cioè di quella del fiume Tresa dal pelo ordinario del lago Maggiore al pelo ordinario del lago di Lugano, vien detto, che a quell`epoca, trovandosi il pelo di quest`ultimo di met. 0,3 superiore alla massima magra, e met. 2,172 inferiore alla massima piena, si riconobbe che nella Tresa scorrevano 907 once milanesi d’acqua. Qui probabilmente è corso un equivoco o nel determinar l’erogazione, o nel dichiarare che il pelo del lago di Lugano era soltanto met. 0,30 superiore alla massima magra; ed il secondo caso è il più probabile. Infatti a met. 0,30 sopra la massima magra il lago sarebbe stato poco più alto della magra ordinaria, mentre sopra si è detto che i due laghi trovavansi nello stato ordinario. Altronde, se il pelo del lago fosse stato superiore soli met. 0,30 alla massima magra, ed inferiore di met. 2,172 alla massima piena, la massima differenza de` due peli del lago non ammonterebbe che a met. 2,472, mentre una tal differenza ammonta invece a met. 3,21, come rilevasi dalle Notizie Statistiche inserte nella carta topografica dell’Istituto geografico, e riportate più avanti. È quindi più probabile che il pelo del lago si trovasse a quell’epoca superiore alla massima magra più di met. 0,30.
[6] Il sig. ing. Fumagalli valuta questa superficie a 43 milioni di m.q. La gran carta topografica della Lombardia la valuta a 0,881 miglia quadrate di 15 al grado, cioè di 48300000 m.q. circa, ciò che risulta parimenti dalle Notizie Statistiche intorno ai fiumi, laghi e canali delle provincie lombarde publicate dalla Direzione generale delle publiche costruzioni (Milano, 1833), in cui la detta superficie è valutata a 14,10 miglia geografiche quadrate di 60 al grado.
Nelle Notizie Statistiche, unite alla carta topografica della provincia di Como de` geometri Monticelli e Marzoni (1824), la superficie del lago di Lugano viene indicata di 58800000 m.q.
[7] Questi dati sono quegli stessi delle Notizie Statistiche citate nella precedente nota, a riserva che le tre ultime altezze sono aumentate di met. 0,40 per correzione d`un equivoco accaduto nella citata opera.
[8] Per provare una tale asserzione farò vedere, che, col mezzo della Chiusa regolatrice, il lago di Lugano può somministrare 45o once al fiume Tresa dal 12 aprile al 22 maggio a vantaggio del Naviglio Grande, once i io allo stesso fiume dal 22 maggio al io agosto per la rotazione de` mulini, ed altre once 45o dal io agosto al 3o dello stesso mese in caso di massima magra a vantaggio del Naviglio stesso, e finalmente once 200 al canale dal 12 aprile al 12 maggio, tempo del minor bisogno d`acqua, ed once 400 dal 12 maggio al 3o agosto; e tutto ciò supponendo che in questo periodo di tempo avvengano i casi più straordinari di mancanza d`acqua, che possano imaginarst, e senza che con ciò si cagioni veruna depressione del pelo del lago al dissolto della sua massima magra. Suppongasi infatti che le portate del fiume Tresa ne`tre stati di magra massima, di magra ordinaria, e di pelo ordinario o mezzano, siano rispettivamente di met. cub. 15 e 30 per ogni minuto secondo, corrispondenti ad once 283, ad once 425 e ad once 850 1/3. E queste portate sono certamente minori delle vere, giacché ritenuta la larghezza media del fiume Tresa di met. 4.0 e la sua pendenza di 1/1800„ come riscontrò il sig. ing. Fumagalli, le altezze medie della Tresa in questi tre stati, calcolate colla formola di Tadini p x (L2 x A3 / Q2) = 0,0004, sarebbero rispettivamente di metri 0,356, 0,466 e 0,740; altezze che sono senza dubbio molto al dissotto delle vere. Suppongasi inoltre, che dal 12 aprile fino al 22 maggio continui, per un caso strano, un` ostinata siccità, ossia una massima magra; che dal 22 maggio, tempo in cui solitamente hanno luogo le abbondanti piene di primavera, sopragiungano invece le sole acque mezzane, che durino soltanto fino verso il 21 giugno, altro caso altrettanto straordinario; che a quest`epoca, in cui al cessare delle piene suol seguire uno stato d’acqua mezzano, che prolungasi sino alle magre di settembre, segua invece uno stato di magra ordinaria che duri solo fino al io d`agosto; e che finalmente, anticipandosi di 20 giorni le solite magre ordinarie di settembre, abbia principio al io agosto, non una magra ordinaria soltanto, ma una magra massima, che duri fino alla fine del mese.
Ammesse tali supposizioni, le quali forse mai non si accumuleranno tutte in un anno solo, la quantità d`acqua, che influirebbe nel lago dal 12 aprile al 3o agosto, sarebbe come segue:
Dal 12 aprile al 22 maggio, che sono giorni 40, ossia 3456000", in ragione di 10 m.c. per 1" m.c. 34560000
Dal 22 maggio al 21 giugno, cioè per giorni 30, pari a 2592000", in ragione di 30 m.c. per 1" m.c. 77760000
Dal 21 giugno al 10 agosto, cioè per giorni 50, ossia 4520000", in ragione di 15 m. e. per 1” m.c. 64800000
Dal 10 al 30 agosto, cioè per giorni 20, ossia per 1728000", in ragione di i m.c. e. per 1" m.c. 17280000
E così in tutto, in 140 giorni met. cubi 194400000
L’acqua poi, che derivar dovrebbesi colla Tresa e col canale, sarebbe come segue:
Dal 12 aprile al 12 maggio, che sono giorni 30, in ragione di 23 m. e. per 1", pari a circa once 650, di cui 450 alla Tresa e 200 al canale, formanti in tutto m.c. 59616000
Dal 12 maggio al 22 maggio, che sono 10 giorni, ossia 864000", in ragione di 3 m.c. per 1", ossia d`once 850, di cui 450 alla Tresa e 400 al canale mc. 25920000
Dal 22 maggio al io agosto, che sono 8o giorni, ossia 6912000", in ragione di m. c. 18 per i", cioè d`once 510,
di cui 400 al canale, e 110 alla Tresa mc 124416000
Dal 10 agosto al 30 agosto, che sono giorni 20 in ragione di 30 m.c. come dal 12 al 22 maggio m.c. 51840000
E così in tutto m.c. 261792000
Deducasi l`ammontare dell’influente m.c. 194400000
Rimarrà da estrarsi dal bacino del lago. m.c. 7392000
Ed essendo la superficie del lago di 50 milioni di metri quadrati, l’altezza d`acqua da estrarsi sarà di m. 1548. Se adunque, col mezzo della chiusa regolatrice, si preparasse, pel 12 aprile, il pelo del lago di m. 1,348 superiore alla massima magra, cioè met. 0,248 al disopra del pelo mezzano, si giungerebbe al 30 agosto coll`aver ridotto il lago allo stato di pelo minimo, allo stato cioè della massima magra, che si è supposto aver luogo a quell`epoca.
[9] Dai citati rapporti fra le superficie dei tre laghi e quelle de` loro domini fisici bisogna inferire che il lago di Lugano offre una singolare irregolarità per rispetto agli altri due; in ciò, che la quantità annua media d’acqua, in esso influente, è molto maggiore di quella che competerebbe alla superficie del sua dominio fisico. Una tale osservazione non è nuova, giacché a pag. n 9 delle Notizie Statistiche de` Fiumi., Laghi e Canali vien detto: «Si ritiene che questa lago sia alimentato e nutrito per dissolto dalle acque contenute nel seno de monti che gli fanno corona; giacché quelle che vi • portano gl`influenti non possono supplire all`evaporazione ed all’emissario della Tresa.
Non solo poi è probabile un tale supposto, ma è forza ammettere che il lago di Lugano sia alimentato anco dalle acque giacenti apparentemente ne` dominj fisici degli altri due laghi. In fatto il dominio fisico della Tresa sta a quello del Ticino a Sesto Calende, come 1:22, e circa se si considera il Ticino imboccatura del Naviglio Grande. Ora in epoca di massime magre, in cui oltre al doversi fare una sopracchiusa alla paladella della Ca`-della:Camera per dar la sua competenza al Naviglio, bisogna pur chiudere la bocca di Pavia, non decorrono nel Ticino più di i5oo onCe d`acqua. Perloché, a pari circostanze nel resto, la portata della Tresa non potrebbe essere che di once 64, cioè a dire non potrebbe aver più di met. o,i .d’altezza sopra 3o di larghezza. Se poi si considera, che, in proporzione dei rapporti esistenti tra le su, perficie de` laghi e quelle de`loro dominj. fisici, la perdita per evaporazione nel lago di Lugano dovrebbe essere séstupla di quella del lago Maggiore., se ne deduce che a cose pari la Tresa in massima magra non dovrebbe dare una goccia d’acqua; ciò che non si è mai verificato».
[10] Applicando queste dimensioni, alla fornaola di Tadini, la portata sarebbe di 2804 m.c. per 1". Tanta differenza fra il risultato di questa iormola e della formola d’Eytelwein deve porre in gran diffidenza l`Idraulico che ha da farne uso; quest` ultima però merita assai maggior fiducia per tutti i rapporti, sotto però tutte le riserve, di cui feci parola nella mia Memoria sulla Sistemazione dell`emissario sul lago di Como.
[11] Questi prezzi però non potrebbero servir di norma nel caso attuale, in cui deve porsi in conto: la spesa straordinaria di trasporto, la quale non potrebbe esser minore delle lire 2 per ogni m. c.; 2.0 la spesa dell’estrazione artificiale dell`acqua di filtrazione col mezzo delle trombe; 3.° la maggior perdita di tempo degli operai nel togliersi e recarsi al lavoro; 4.0 il minor numero d’ore di lavoro, che sostener potrebbe giornalmente operajo in causa dell’insalubrità del luogo, circostanza che l’°litigherebbe a risalire di tempo in tempo all’aria libera; 5.0 la spesa del lume, che sarebbe necessaria ad onta della piccola distanza dei pozzi, l`effetto dei quali, per l’aumento di luce, sarebbe affatto insufficiente; 6.° la minor efficacia delle mine a cagione della maggior umidità, e conseguentemente il maggior consumo di polvere e di giornate. Circostanze tutte che aumenterebbero di molto il prezzo dell’estrazione d’un metro cubico di materia in confronto di quello delle Gallerie ordinarie.
[12] Specie di scalpello più o meno lungo e grosso, la cui estremità temprata, invece di terminare in punta, termina in forma d`un dente tagliente di ruota dentata; col cui mezzo si perfora la pietra, battendo colla mazza sull’altra estremità dello stampo, il quale ad ogni colpo si gira in modo che lo spigolo del dente colpisca la pietra in posizione diversa, affinché il foro riesca di forma circolare. Spinto il foro a convenevole profondità vi si pone lino a certa altezza la polvere, e se ne riempie il rimanente con terra argillosa ben battuta, che fa da stoppaccio, lasciandovi però un piccole eoudetto, che serve a counnunicare l’accensione alla polvere.
[13] Le difficoltà, che può presentare questa contemporaneità d`operazioni, non devono figurarsi tali da compromettere l’esecuzione del progetto o au mentarne straordinariamente la spesa di costruzione. Qui non v`ha alcuna delle immense difficoltà incontrate nella costruzione del Tunnel sotto il Tamigi, come taluno potrebbe andar irnaginando, ove tali difficoltà procedevano totalmente dalla enorme massa d’acqua soprastante a poca distanza della volta della galleria, il cui peso cresceva a dismisura durante la marea. Non è quindi in questo caso menomamente necessario il costosissimo mecanismo, che si dovette porre in opera in quella gigantesca impresa, nullo essendo il pericolo, contro il quale quel mecanismo fu divisato. Ogni qual volta s`incontrasse il bisogno d`una costruzione di muro e vòlta contemporaneamente all`escavazione della terra, basterebbe escavare primieramente per un metro di lunghezza o più, secondo i casi, e due metri di larghezza in un lato della galleria, sostenendo la terra con opportuni tavolati, trattenuti da corrispondenti sbadacchi, e costruir quindi il muro della parete fino all’altezza dell’imposta della volta; né gli sbadacchi sarebbero del menomo impedimento, servendo anzi a lasciare ne muri stessi i necessarj sfori. Lo stesso si potrà fare, o contemporaneamente, o subito dopo, secondo che si troverà più convenevole, all`altro lato. Costruiti in tal modo i muri laterali, s`introdurrebbe nella terra rimasta nel mezzo, e qualche centimetro sopra la volta, una superficie cilindrica di ferro fuso, in una o più fasce abbraccianti la faccia della valta da assicurarsi co` suoi lati orizontali sui muri costruiti. Con ciò potrà levarsi tutto il maschio di terra lasciato nel mezzo della galleria, e costruirsi tosto con tutta facilità il corrispondente tratto di volta, estraendo poscia l’armatura di ghisa posta provisoriamente a sostegno delle terre superiori. Né l`introduzione di codesta armatura dovrebbe richiedere l’impiego di grandi forze, perché, ove si facesse luogo a questo caso, ivi non sarebbe necessario questo mezzo speciale per evitare gli scoscendimenti di terra.
[14] Un primo scaricatore si potrebbe costruire appena si fosse giunto col fondo del canale a livello del fondo dell`Olona, ciò che avverrebbe presso a Vedano, ed alla distanza di circa met. 19 mila dalla bocca di derivazione, ritenuto, come feci osservare più sopra, che la platea inferiore del mulino di Gurone è di met. 9, o6 inferiore, e non superiore al pelo del lago. Questo primo scaricatore dovrebbe anzi essere una delle prime opere da costruirsi, nel caso che la galleria avesse a lasciare la valle dell’Olona prima di sboccare in essa, e ciò alr oggetto di presentare il più presto possibile un libero sfogo alle acque filtranti diminuendosi così una parte delle spese della loro artificiale estrazione dai pozzi col mezzo di trombe.
- A Cura di:
- [Francesco Malingamba]
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
Magazzeno Storico Verbanese
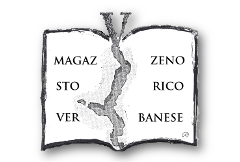 A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
Biografia Carlo Alessandro Pisoni
Carlo Alessandro Pisoni (Luino, 1962 - Varese, 2021). Seguendo le orme del padre Pier Giacomo, dal 1991 al 2017 è stato conservatore, per gentile concessione dei principi Borromeo, dell'Archivio Borromeo dell'Isola Bella. Appassionato studioso e ricercatore, ha sempre voluto mettere a disposizione degli altri conoscenze e scoperte, togliendo la polvere dai fatti che riguardano Lago Maggiore e dintorni; insieme a studiosi e amici, ha riportato alla luce tradizioni, eventi e personaggi passati dal lago, condividendoli con la sua gente.
