STRUMENTI CULTURALI
del Magazzeno Storico Verbanese
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
- Denominazione:
- Santa Caterina Del Sasso
- Breve Abstract:
- V. De Vit, Il Lago Maggiore..., Vol. 02 p. 1 - Vita del B. Alberto Besozzi - 03. Vita del Beato Alberto.
- Abstract:
VITA
DEL
BEATO ALBERTO BESOZZI
La semplicità è una delle più belle doti di uno scrittore delle Vite de’ Santi; e tale è il pregio dell’autore anonimo della Vita del nostro Beato. Noi procureremo d’imitarlo, per quanto ci sarà possibile, seguitando passo passo il suo racconto, ed inserendovi opportunamente quelle poche notizie, che abbiamo trovate sparse qua e là negli scritti di quelli che ci precedettero, per dar compimento in qualche modo al nostro lavoro. È vero che sono poche le notizie ch’essi ci tramandarono intorno al Beato Alberto; sono però sufficienti per farci abbastanza comprendere a quale altezza di perfezione egli sia giunto, e quale profitto possiamo nondimeno cavarne leggendole con attenzione.
Il Beato Alberto, secondochè dalle cose esposte di sopra ci è dato conghietturare, nacque al più tardi verso la metà del secolo XII, non si sa precisamente in qual luogo, e molto meno in qual anno. È costante tradizione presso tutti gli scrittori della sua vita, che sia uscito dell’antica e nobile famiglia de’ Besozzi, così denominata dall’illustre borgo di Besozzo sul Lago Maggiore, alquanto entro terra (7).
Incerto poi è il nome dei suoi genitori, e incerte le memorie de’ suoi anni giovanili e della sua educazione. Alcuni lo vogliono già fino dalla sua fanciullezza guastato dal corrotto costume del secolo in cui viveva, ed altri all’incontro assai cristianamente educato da’ suoi genitori, così che potesse dare sino dai primi anni saggi di non comune pietà, e crescere poi in bella fama di giovane onesto e timorato di Dio. Ciò che mi fa propendere a questa seconda opinione, colla quale rimane conciliata anche l’altra relativamente alla sua mala condotta posteriore, si è il trovare nella sua famiglia verso quel tempo tracce di pietà, e più di tutto la sua devozione, come diremo, a Santa Caterina, devozione che non potè sorgere dal cuore di Alberto così di un tratto e in quel punto, ma che dovette anzi risvegliarsi in lui, come un resto od una reminiscenza della sua prima educazione.
Raccontano inoltre gli scrittori della sua vita, che rimasto per tempo orfano del padre, e lasciato erede di un pingue patrimonio, menasse in moglie una donna assai commendevole non tanto per la nobiltà de` natali, quanto per le sue specchiate virtù, colla quale vivesse alcuni anni in concetto di ottimo cittadino. Ma questo pure è assai incerto, come incerto parimente è il nome della moglie e del casato di lei, checchè altri abbiano potuto dirne. Quello però che viene fuori di ogni dubbio e concordemente asserito da tutti gli scrittori della sua vita, è ch`egli fosse assai ricco e in pari tempo dominato dalla cupidigia di divenir tale ogni dì più, riconoscendo essi in questo suo attaccamento alle ricchezze la funesta cagione del suo traviamento. Infelice colui che poi beni caduchi di questa misera terra sacrifica quelli della patria celeste! Alberto affascinato dallo splendore dell’oro, di cui diveniva sempre più avido senza rimanerne mai sazio, si lasciò trascinare agli eccessi più riprovevoli. Tutte le arti della frode, i raggiri e le astuzie, che i figliuoli del secolo sogliono chiamar talora col nome di prudenza, le usure e le più aperte ingiustizie si erano rese a lui così famigliari da perderne financo il rimorso (8).
Non è di dire quanto la savia moglie se ne addolorasse, e come si struggesse in amare lagrime dinanzi a Dio implorando misericordia pel traviato suo sposo. «Una moglie fedele, è detto nella Sacra Scrittura, santifica il marito infedele.» Le sue lagrime da ultimo ne impetrarono la conversione. Iddio che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, colla sua longanime pazienza aspettavalo al varco, quando Alberto meno so lo attendeva.
Mentre se ne tornava un giorno dal Vergante (9) tutto lieto per aver dato fine a certo affare molto lucroso, tragittando il Lago Maggiore su di una leggera barchetta, ecco d’improvviso levarseli incontro una furiosa procella. Già le onde con impeto assalgono quel fragile legno e minacciano d’ingoiarlo. I barcaiuoli indarno si affaticano di guadagnare la sponda, che il guizzo dei lampi in un cielo già tutto coperto di nubi, mostra loro invece non lontani que’ scogli, incontro ai quali correvano come ad inevitabil naufragio. Che fa egli Alberto in sì terribil frangente? Alberto alla vista di quell’imminente pericolo riscosso come da profondo letargo volge rapidamente il pensiero a quella vita futura, alla quale non aveva mai pensato da lungo tempo. Misero! gli assopiti rimorsi gli si ridestano ora ili lutto il loro vigore e lo straziano senza ristoro: paventa il formidabile giudizio di Dio, che già si tiene imminente, e tuttavia stupido e irresoluto non sa formulare un pensiero, che valga a riconciliarlo col suo Creatore.
Frattanto la già sdruscita barchetta corre a precipizio tra’ scogli, urta e s’infrange, ed Alberto, quasi per istinto aggrappatosi ad una tavola del legno infranto, è vivo ancora, ma vivo come chi aspetta di minuto in minuto la morte. Era questo il momento della misericordia. Un raggio di essa suscita in Alberto quella fede che non era ancora estinta del tutto, sicchè rinata ben presto in lui la speranza, egli prega e prega di cuore, promettendo con voto, che se Iddio pei meriti della gloriosa sua serva Santa Caterina (10) lo avesse campato da quel naufragio, avrebbe riparato ogni danno, e, fatta in un eremo penitenza sincera de’ suoi delitti. Iddio mai non disprezza un cuore contrito e profondamente umiliato. La tavola, sulla quale Alberto si aspettava di essere ad ogni istante ingoiato dallo onde, è spinta da quello stesse verso uno scoglio, ed egli afferratosi a’ bronchi della rupe vicina, e fattosi di que’ sassi scala a salirvi, trova in essa alla fine scampo e salute (11).
Di là come risuscitato da morte misura di un guardo tutto tremante il passato pericolo, e mosso da un inesprimibile affetto, il solleva al cielo ed esclama a gran voce: Una rupe fu per tua bontà mia salvezza, una rupe sarà testimonio della mia penitenza.
Rese pertanto in quel luogo stesso le dovute azioni di grazie al suo Dio, ed alla Santa vergine Caterina sua interceditrice, si affretta a riveder la famiglia. Narra anzi tutto alla moglie sbigottiva la trascorsa vicenda e insieme il voto da sè fatto di vivere quindi Innanzi in un qualche eremo una vita di rigida penitenza. La moglie tutta esultante di gaudio in quel Dio che aveva esaudite con infinita bontà le lagrime sparse in pro del marito, ben di cuore a lui si unisce nel rendergliene i più fervidi ringraziamenti, e non avendo figliuoli, volenterosa gli acconsente la separazione,(12) col fermo proposito, secondo il detto di alcuni, di ritirarsi essa pure in un monastero.
Sparsasi tostamente per ogni dove la notizia di questo fatto, invano si sforzarono i loro parenti ed amici di stornare una così santa risoluzione: invano loro allegarono la nobiltà del lignaggio e la famiglia estinta con essi: invano gli rappresentarono estorto quel voto più presto dalla paura, che dalla persuasione del cuore: invano finalmente lo pressarono a chiederne commutazione. Alberto divenuto ormai altro uomo, non ode che la voce di Dio che lo vuol tutto suo, e coraggiosamente disprezza quelle della carne e del sangue, che lo vorrebbero ancora in mezzo alle onde procellose di questo secolo.
Perciò dopo di aver preso un sufficiente ristoro e riveduti prima di ogni altra cosa i suoi conti con Dio, se ne va tosto ai piedi di un confessore per detestarvi i suoi falli e lavarsi in quel bagno salutare di penitenza. Così appieno riconciliato con Dio, si affretta a dar ordine a’ suoi affari. Restituisce quindi con usura a somiglianza del pubblicano dell’evangelio, il mal tolto, e, stabilita una conveniente dote alla moglie, di tutto che gli rimane fa generoso dono ai poverelli di Cristo e, sciolto da ogni ingombro terreno, vola su di una barchetta in cerca di una caverna atta al divisato proponimento. La trova poco lungi dal luogo del suo naufragio, in un orrido sito denominato da un masso che sembra precipitarsi nel lago, il Sasso Ballaro, e, licenziati i barcaiuoli e dato un solenne addio alle cose tutte del mondo, quasi in arca di salute,(13) ivi si adagia.
Quale mutazione! Quell’uomo, che poco prima nuotava nell’abbondanza, eccolo ora ridotto per solo amore di Cristo nella miseria più squallida. Di tutte le sue ricchezze non gli rimane che un vaso di creta per bere, ed un cestello di giunchi che egli cala per una fune da un’apertura di quella rupe, onde implorare dalla pietà dei naviganti un tozzo di pane a sostenere la vita. Il uso letto è quivi il duro sasso; il suo vitto poco pane, se gliel’offre la carità, oppure l’erba di que’ dintorni, e condimento di questo le sue lagrime: tutta la sua compagnia una rozza croce di legno formata dalle sue mani! Eppure il cuore n’è pago, e traboccante di gaudio. Emulo degli anacoreti più celebri della santa Chiesa, degli Antonii, dei Paoli, d,gli Ilarioni, non pensa che a macerare la propria carne per ridurla soggetta perfettamente allo spirito. Le sue preghiere salgono quale odoroso incenso al trono del Dio di tutte misericordie e ne riceve le più soavi consolazioni. Oh! quante volte rammentando le sue passate follie, cadde boccone sul nudo suolo disfacendosi in lagrime del più cocente dolore: vero spettacolo di delizia a quegli angeli, che a detta del Salvatore più fanno festa su in cielo per un peccatore che si converte, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza.(14)
Dieci anni (15) passò il magnanimo Alberto tra gli orrori di quella caverna, ed in mezzo alle più fiere battaglie del comune nemico, quando la fama della sua ammirabile penitenza, già diffusa per tutto il Lago Maggiore, trasse parecchi a visitarlo ed a consultarlo. Temette I’umile servo di Dio, che quelle visita potessero divenirgli inciampo al cammino della perfezione, alla quale tendeva, e raddoppiò i suoi rigori. Si astenne quindi dal calare il cestello per riscuotere quella elemosina, che gli veniva offerta dai naviganti, e restrinse volontariamente il suo vitto all’erba cruda, ed a qualche frutto, che nasceva spontaneo tra i bronchi di quello scoglio: sicchè non più vedendosi dai naviganti il consueto costello, egli fu tenuto generalmente per morto.
Aggradì il Signore questo nuovo sacrifizio del generoso suo servo, nè si lasciò vincere in generosità anche quì sulla terra. Più frequenti si fecero a lui le celesti consolazioni, ed è fama che spesse fiate scendessero gli Angeli a confortarlo di quel cibo spirituale, che fortifica l’uomo e lo rende terribile a’ suoi nemici.(16) Se non che, mentre l’umile servo di Dio procurava in questa maniera di tenersi viemeglio celato agli occhi degli uomini, tanto più luminosamente volle Iddio prima ancor della morto rendere loro manifesta la santità di lui con inusitati splendori intorno al suo eremitaggio.(17)
Infieriva allora, verso la fine del secolo XII,(18) una crudelissima pestilenza nella Lombardia e soprattutto nei paesi vicini al Lago Maggiore dell’una e dell’altra sponda. Universale era in questi luoghi la desolazione e il compianto. Tornati inutili tutti i mezzi, che l’arte umana può somministrare, si ricorse alla protezione celeste. Un vecchio sacerdote di que’ dintorni si risovvenne in tale circostanza di Alberto, e ignorando s’egli fosse realmente, come si temeva, passato di questa vita, volle farne ricerca. Portatosi quindi a quella spelonca e trovatolo non senza grave difficoltà tra quegli orrori non più quasi riconoscibile, colla dolorosa narrazione de’ mali, da’ quali erano afflitti i paesi tutti circonvicini, intenerillo per siffatta maniera che Alberto, quantunque a principio ricusasse per umiltà di farsi colle sue preghiere mediatore appo Dio per la cessazione di un sì terribile flagello, cedette alla fine e promise le sue lagrime e la sua penitenza a placare la collera dell’Eterno giustamente adirato pei peccati degli uomini: venisse pertanto dopo otto giorni che gli darebbe risposta della volontà del Signore.(19)
E questi rispose in vero propizio alle preghiere di Alberto manifestandogli col mezzo degli Angeli essere sua volontà, che su quello stesso scoglio da lui trascelto a luogo di sua penitenza si erigesse una piccola chiesa in onore di Santa Caterina, secondo la grandezza di quella del suo sepolcro nel monte Sinai, e non maggiore, nè minore, e sarebbe così cessata la pestilenza. Alberto non sapeva ove fosse il monte Sinai, nè aveva inteso mai parlare di quel sepolcro, molto meno poi delle sue dimensioni: onde l’angelo a confortarlo ne’ suoi timori, soggiunse, che gli sarebbe dato il segno e della misura e del luogo, ove quella chiesa doveva farsi. Difatti nella mattina seguente trovò un luogo bagnato e disegnato in quadro angolare sopra il sasso secondo Ia predetta rivelazione. Ed aggiunge lo storico, che ci è guida in tutto questo racconto, che la chiesa quivi dedicata in onore di Santa Caterina fu trovata poi in tutto corrispondente al sepolcro di lei sul monte Sinai.(20)
Otto giorni appresso, secondo che avevano stabilito, quel Sacerdote ritornò a lui accompagnato da molti del popolo tutti lieti per la ricevuta notizia che Alberto ancora viveva. Ma qui non incresca di leggero narrato per disteso questo fatto colle parole stesse del nostro cronista.
«Fatto questo, al giorno deputato tornarono quelli, che una sì grande e salutifera cosa si erano messi a fare, e trovarono l’uomo di Dio allegro per la speranza della loro a salute, e disse: Ringraziate senza fine l’onnipotente Iddio, il quale ha esaudito le voci di quelli, che piangevano, e per sua divina clemenza ha posto fine a così grande pestilenza; ma per comandamento di Dio sia edificata una chiesa in questo luogo secondo la grandezza del sepolcro di Santa a Caterina vergine nel monte Sinai. Quegli uomini divoti piangendo per allegrezza promisero volentieri di eseguir tal precetto, e dimandandogli in che modo la calcina, l’acqua e le pietre e le altre cose necessarie a tal fabbrica si sarebbero lassù condotte per l’asprezza e incomodità del luogo.
«Disse l’uomo di Dio: Non temiate, perché chi ha fatto la grazia, e ha espresso la divina volontà, darà aiuto ancora e modo a’ fedeli di compir quello che ha comandato.» (Capo VIII).
«Confermati adunque gli animi di tutti, allegri se ne tornarono a casa, e fu la peste in tutto estinta, che non morì più alcuno. Così subito diligentemente cominciarono a preparare tutte le cose necessario per tant’opera comandata loro, e perchè a far la fabbrica poche cose bisognavano, e vi concorsero molti popoli, in pochi giorni fu ridotta a compimento la Chiesa piccola per grandezza, ma grandissima per lo molte grazie da Dio concesse in quella: nè i lavoratori sentirono fatica alcuna, e quasi si dolevano, che non avessero avuto maggiore occasione di stancarsi in una fabbrica, che tanto volentieri facevano, e così, quasi che niente affaticandosi, compirono quelle cose che prima per la scomodità del luogo non gli pareva possibile di poter ridurre a perfezione e come se non avessero fatto cosa alcuna, quasichè lor pareva di aver sognato.» (Capo IX).
Tale è l’origine di quel Santuario chiamato ancora oggidì dal masso calcare che pende sopra la Chiesa, col titolo di Santa Caterina del Sasso, la cui fama in brevissimo spazio di tempo si sparse per molta parte d’Italia e anche oltremonti. Così quell’uomo, che si era ritirato dal mondo per non avere più nulla di comune col mondo, divenne pure, nella sua medesima povertà e solitudine, un grande benefattore del mondo!
Aggiunge il Guazzo (21) che, fabbricato il luogo, concorreva grandissima moltitudine di popoli a visitare il santo mausoleo della V. e M. Caterina, dove, veduta la comodità di vita ritirata, molti supplicarono il B. Alberto a compiacersi di accettarli in sua compagnia per potere sotto i suoi ammaestramenti attendere al servigio di Dio in santa penitenza in quel medesimo luogo, ma che l’uomo di Dio, non consentì alla loro petizione e solo si accontentò che vi restasse un sacerdote, il cui ministerio potesse dare soddisfazione ai forestieri pellegrini e a chi concorreva alla visita del sacro luogo. E aggiunge di più che temendo Alberto il conversare con gli uomini, avrebbe voluto volentieri mutato luogo, se non ve lo avesse trattenuto il voto, che aveva fatto.
Se non che Iddio, il quale aveva già purificato il suo servo e resolo ormai maturo pel cielo, non volle differirgli più a lungo il premio dovuto alla sua penitenza. Narrano che pochi giorni dopo quel fatto, egli fu sorpreso che una lenta febbre, che gli fece presagire vicino l’ultimo giorno. Chiese pertanto al suo Dio gli estremi conforti pel suo imminente passaggio, ed un sacerdote venne, così inspirato da Dio, a visitarlo in quella spelonca e a ricevere l’ultima sua confessione: onde anche in breve munito degli altri sacramenti, volò ricolmo di meriti il giorno 3 di settembre agli eterni gaudii del Paradiso.(22)
(8) Ecco il capo II del nostro manoscritto, che fa seguito al primo riportato di sopra nell’Introduzione (p. 41): «Un certo gentiluomo chiamato Alberto de’ Besozzi, quale avea moglie, ma senza figliuoli, avendo accumulate molte ricchezze con gran carico di coscienza per aver ingannato molte persone, se ne viveva nondimeno ostinatamente con ingordigia di acquistar maggior facoltadi.»
(9) Non si sa precisamente da qual luogo del Vergante. La nostra guida dice che tornava dal mercato: il Guazzo da alcuni luoghi al di là del lago, e il P. Annibale Besozzi, che fu sorpreso dalla burrasca nel passar che faceva colla sua nave dalla riva opposta del Vergante a quella di Movallo. Da questi brevi raffronti pare che si possa dedurre con sicurezza, che il mercato, da cui Alberto era partito, fosse quello di Lesa, il più antico nel Vergante, ed il quale sappiamo essere stato tenuto sino all`anno 1312, in cui venne lavato e concentrato in quello di Arona. Vedi il Medoni nelle sue Memorie Stor. di Arona, p. 95.
(10) Il culto di questa Santa vergine e martire d’Alessandria in Egitto uccisa in odio di Cristo sotto l’imperatore Massimino al principio del IV secolo dell’era nostra, era intorno a questi tempi più che mai diffuso nell`oriente, donde in breve si sparse pure nell’occidente per opera de’ Crociati, che reduci da terra santa vi recarono la notizia delle grazie da essi ottenute per l’intercessione di lei. Vedi tra gli altri il Galesini nelle note al Martirologio Romano (Milano, 1578, in 8.°), sotto il giorno 25 novembre, che è il natalizio di questa vergine. - Intorno poi alla traslazione del suo corpo gioverà riferire ciò che scrive Monsignor Falconi, Arcivescovo di S. Severino (Comment. ad Capponianas Tabulas Ruth. Romae, 1755, p. 36, presso il Moroni, Dizionario di erudizione Storico-Eccles. Venezia, 1841, Vol. X, p. 259: «È detto che il corpo della Santa fu portato dagli Angeli sui monte Sinai, lochè significa che i monaci del Sinai lo portarono nel loro monistero per arricchirlo di si prezioso tesoro... Si sa che l`abito monastico fu detto sovente abito angelico e che anticamente i monaci erano chiamati angeli.» Alla difesa poi di questo corpo fu istituito intorno all’anno 1063 o 1067, un Ordine equestre detto di S. Caterina o del Monte Sinai, od anche di Gerusalemme. Vedi Giustiniani, Historiae Cronologiche degli Ordini equestri, p. 121.
(11) Più scrittori misero in versi il naufragio e la conversione di Alberto. Non sarà discaro ai nostri lettori il seguente epigramma del Bulzio nel suo Larario poetico:
Per fas perque nefas fluxi cupidissimus auri
Albertus lydium quaeritat arte lucrum.
Divitiis inhians fluidis dum navigat undis,
Infremit horrisono dira procella freto.
Naufragio propior pravos componere mores
Is vovet, et placidis pinus oberrat aquis.
Exiit ut pelago, scandit iuga inhospita montis,
Et vacat hic uni per Pera tesqua Deo.
Ne mare dic furem: raptam Plutone et ab ipso
Ecce animam Domino restituit supero.
È riportato dal Bosca nelle annotazioni al Martirologio Ambrosiano pag. 276, ove nota l`errore del poeta circa il luogo della burrasca patita dal B. Alberto. Ivi riporta anche l’epigramma del Brauzio nel suo Martirologio poetico:
Albertus voto salvos, periturus in undis,
Coniugis assenso pauper in anatra migrat.
ed osserva, che tutti e due questi poeti, forse aderendo al Galesini, chiamarono il nostro Alberto col titolo di Santo, in luogo di quello più comune, e che solo gli compete, di Beato.
(12) Il nostro manoscritto cosi prosegue il racconto al capo III. «Accascò un giorno tornando dal mercato, che la nave, nella quale si trovava del lago ivi appresso pareva che si sommergesse. Alberto come ancor gli altri, e forte più per la gravezza de’ suoi peccati temendo la morte, anzi vedendosela davanti gli occhi, mosso a penitenza cominciò con tutto il cuore voltarsi a Dio, e fece voto che se per i meriti della Santa e gloriosa Caterina scampava dalla morte e non periva in quel terribile naufragio, avrebbe del tutto lasciato il mondo; e cercato un eremo, e ivi finirebbe la vita sua. Dal qual pericolo fu liberato, avendo il Signor Iddio veduta l`afflizione dell’animo suo. Così andatosene a casa narrò alla moglie e agli altri quanto gli era occorso, e stando fermo nel voto, fece testamento restituendo il mal tolto, dando alla moglie di poter vivere, il resto distribuì seco condo I’ispirazione di Dio.»
(13) La Santa Chiesa in questi casi, come anche era in uso nei primi secoli del cristianesimo, s’intendeva che tacitamente dispensasse dall’obbligazione di certe leggi e precetti di culto esterno coloro, che si ritiravano in qualche solitudine a menar vita di penitenza. Ne abbiamo frequenti esempi nella storia ecclesiastica. Ricorderò tra gli altri quello di Santa Rosalia, vergine palermitana, la quale, fuggita di casa in età ancor giovanile, visse sino alla morte nello squallore di una caverna tra le montagne della Sicilia.
(14) Capo IV. «Partendosi dunque e lasciando i parenti e gli amici che piangevano, e ringraziando l’onnipotente Iddio, entrò in una barchetta e navigando cercò un pezzo per salire in un luogo deserto, sassoso e pieno di spine e sterpi, dove non abitasse alcun uomo: finalmente vedendo un luogo a modo suo lasciando i barcaiuoli e facendosi forte con il segno della Santa Croce salì i luoghi più sassosi e deserti, e cercando un luogo comodo per riposo del corpo trovò una caverna, la quale, come si dice, è ora vicina, e quasi contigua alla chiesa. Nè seco aveva portato se non un cestello ed una corda, le quali due cose adoperava per vivere mandando giù per il monte il cestello con la corda alle navi, che gli facevano elemosina di pane e di altri cibi.»
Il vaso da bere è ricordato dagli altri scrittori.
(15) Questa data è tratta dal Compendio citato del B. Annibale Besozzi, e fu seguita dal recente autore delle Notizie storiche. La nostra Narrazione manoscritta dice semplicemente in spazio di tempi. Questa omette anche le visite avute dal B. Alberto in quel luogo.
(16) Ecco il capo V del nostro manoscritto. «In spazio di tempi lasciò questo costume, perocchè il Signore ch’è scrutatore de’ cuori siccome aveva invisibilmente illuminata la mente sua, così visibilmente gli confortò gli occhi corporali colla consolazione della visione angelica. e così lungamente pasciuto dall`angelo senza mai veder gente umana se ne stette nel deserto a contemplare, e questa vita fece tanto tempo, che non solamente potè da alcuno esser veduto, ma in tutto di lui alcuno più non si ricordava, nè faceva memoria alcuna. È ben vero che dopo molto tempo si viddero più volte nel medesimo luogo certi splendori di lume: con tuttociò ognuno credeva che già fosse morto.»
(17) Il Ferrari concorda in questo fatto col nostro manoscritto quanto alla sostanza, differisce però in alcune particolarità. Ecco le sue parole: Cum autem ab angelis pastus cistam lagenamque demittere per multum temporis cessasset, et a navigantibus et incolis finitimis mortuus crederetur, splendor quidam inusitatus circa illius tugurium apparuit, quo tempore ingens vigebat pestilentia, sacerdotem quendam induxit, Albertum adhuc vivere, populisque finitimis suaderet ad illum accurrere, utenza opem eis in tanto flagello ferret.
(18) Ho detto verso la fine del secolo XII, giacchè è incerto l`anno di questa pestilenza. Racconta il Fiamma presso il Giulini, che nell’anno 1187 vi fu una peste maggiore di quante mai se ne rammentino, e che per colmo de’ mali i corvi portavano per aria dei carboni accesi ed attaccavano il fuoco alle case. Il Sigonio invece coll’autorità di sant`Antonino riferisce sì strani mali sotto l’anno 1195, de’ quali però il Giulini non sa se alcuno degli autori contemporanei ne abbia fatto menzione (vedi Giulini all`anno 1187). Che questa pestilenza poi, checchessia dell`anno preciso, sia stata una delle pili terribili calamità che abbia afflitti specialmente questi luoghi, si rileva anche dalla nostra Narrazione manoscritta che qui sotto riporteremo.
Quanto ai luoghi particolari più travagliati da questo flagello, non ho trovato alcuna antica memoria. Solo il Vagliani ed il Bombognini che vissero nello scorso secolo, nominano espressamente i popoli di Suna e di Pallanza tra quelli che ricorsero al Beato in occasione di quella peste. (Vedi Bombognini, Antiquario della Diocesi di Milano, p. 89).
(19) Tutto questo è raccontato dall’Autore del nostro manoscritto: con qualche diversità nelle circostanze dal Ferrari sopra citato e da altri. Ecco intero il capo VI del primo: «Nelli medesimi tempi sopravvenne una grandissima pestilenza, che aveva occupato non solamente una terra, ma quasi tutta la provincia e massime le terre circonvicine del lago, di modo che in pochi giorni molti degli abitatori mancarono, onde facendo i popoli orazione con processioni e litanie, Iddio per sua divina clemenza diede memoria e seguo di questo santo uomo a certi vecchi, che al meglio che potevano, andassero a trovarlo, i quali arrivando alle rive sassose nè trovando modo di andar sopra, né d’alto di calar basso, di nuovo fecero orazione a Dio, e così come poterono arrivarono a quell’uomo di Dio trovandolo barbuto e incolto, che quasi non avea faccia d’uomo. Allora egli alzando gli occhi e temendo le tentazioni del demonio, quali più volte aveva provate, si fece il segno della santa Croce: ma essi dicendogli, ch`erano creature umane e cristiane, gli dimandò loro che cosa si faceva nel mondo, al quale risposero, che non credevano che fosse mai più stato oppresso da cosi grande pestilenza, come era allora, e che quasi tutti erano mancati, né sapevano rimedio di por fine a tante calamità, se la misericordia di Dio non gli soccorreva, onde con grande istanza per la volontà di Dio ti siamo venuti a trovare pregandoti che con li tuoi consigli e preghi siamo aiutati, nè cessi di pregare il Signor Iddio che abbi misericordia di noi, e ponga fine a questa crudel morte. Questo santo uomo, avendo compassione a quei miseri e afflitti con pianto gli disse, andate e dopo otto giorni tornate da me, che vi darò risposta della volontà del Signore.»
Questo racconto scritto con tanta semplicità circa un secolo dopo l`accaduto merita piena fede. Esso è uno dei documenti più importanti per la storia dei nostri luoghi.
(20) Capo VII «Dopo la partita (Alberto) chinatosi in terra cominciò con lacrime a far orazione a Dio che avesse misericordia degli uomini fatti a sua imagine, nè riguardasse a peccati loro; ma che per sua infinita clemenza levasse questa gran peste. Appena compiuta l’orazione, udì una voce angelica, che disse: Alberto, la tua orazione è esaudita. E volontà di Dio è, che qui sia fabbricata una piccola chiesa a in onore della Beata e Santa Caterina secondo la grandezza di quella del Sepolcro suo, ch’è nel Monte Sinai, nè sia maggiore. Rispose quell’uomo di Dio: Io non so dove sia il Monte Sinai, nè tal sepoltura ho mai veduta, quale dunque sarà la misura e qual sarà il luogo? Ti sarà dato, disse l’Angelo, il segno e della misura e del luogo, ove si ha da fare. La mattina seguente vide il luogo bagnato e disegnato in quadro angolare sopra il sasso secondo la misura ed il disegno che volse il Signore, che si fabbricasse; nè fu il disegno maggiore, nè minore, come poi si è trovato esser vero per il sepolcro del Monte Sinai.»
Il riscontro qui notato è degno di considerazione. Il Ferrari ed il P. Annibale Besozzi raccontano che quel sasso quadrato fu trovato cosperso di sangue.
(21) Vita del B. Alberto, p. 74.
(22) In qual anno della sua età sia morto il B. Alberto non è possibile determinare. Il P. Annibale Besozzi lo dice carico più che d`anni, di meriti; e nell’inno che si canta in onore di lui, attribuito da alcuni allo stesso autore, si dice per lustra quinque vixeris. Il Morigia all’incontro nella Storia del Lago Maggiore afferma che fece asprissima penitenza sino all’età decrepita. Il Bombognini poi nel suo Antiquario calcola di 37 anni tutto lo spazio di tempo che il Beato visse entro quella spelonca. Quanto poi al giorno della sua morte gli scrittori sotto quasi tutti concordi. Riportiamo qui i principali elogi, di cui fu in pubblici documenti onorato sotto il giorno 3 di settembre. Il Galesini nel suo Martirologio romano scrisse: In dioecesi item Mediolanensi, sancti Alberti Confessoris; e nelle annotazioni soggiunge che ne trasse memoria da un codice antichissimo della chiesa di Milano, in quo SANCTORUM, quorum in ea dioecesi ecclesiae altariave extant, vitas exaratas vidimus. Nel Martirologio ambrosiano poi, pubblicato e annotato dal Bosca, si ha: Apud lacum Verbanum in dioecesi Mediolanensi natalis B. Alberti Confessoris, qui diu in specu vitam eremiticm duxit ac sanctitate illustris Deo spiritum reddidit. Il Castellano all’incontro nel suo Martirologio Universale lo registra col solo titolo di Venerabile, nel che è contraddetto dall’autore della Vita del Beato appresso i Bollandisti, il quale conchiude: Atque haec quidem, quae de B. Alberto retuli hactenus plus aliquid nihi videntur promereri, quam solum titulum Venerabilis, quo illum nuncupat Castellanus. Da tutte queste testimonianze poi, come anche da quelle recate di sopra del venerabile Bescapè e di altri, risulta evidentemente il culto antichissimo del nostro Beato (talvolta chiamato pure col titolo di Santo), appoggiato come si vede a’ documenti di appena un secolo posteriori.- Autore:
- [Vincenzo De Vit]
- A Cura di:
- [Riccardo Papini]
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
Magazzeno Storico Verbanese
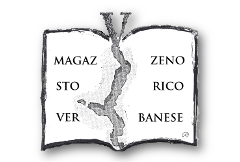 A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.Biografia Carlo Alessandro Pisoni
Carlo Alessandro Pisoni (Luino, 1962 - Varese, 2021). Seguendo le orme del padre Pier Giacomo, dal 1991 al 2017 è stato conservatore, per gentile concessione dei principi Borromeo, dell'Archivio Borromeo dell'Isola Bella. Appassionato studioso e ricercatore, ha sempre voluto mettere a disposizione degli altri conoscenze e scoperte, togliendo la polvere dai fatti che riguardano Lago Maggiore e dintorni; insieme a studiosi e amici, ha riportato alla luce tradizioni, eventi e personaggi passati dal lago, condividendoli con la sua gente.
