STRUMENTI CULTURALI
del Magazzeno Storico Verbanese
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
- Denominazione:
- Santa Caterina Del Sasso
- Breve Abstract:
- V. De Vit, Il Lago Maggiore..., Vol. 02 p. 1 - Vita del B. Alberto Besozzi - 02. Introduzione.
- Abstract:
INTRODUZIONE
Prima di farmi a descrivere una seconda volta le gesta del B. Alberto Besozzi, e di narrare la storia del Santuario di Santa Caterina del Sasso, dove se ne conservano le reliquie, mi chiamo in dovere di esporre ai miei lettori le nuove fonti, alle quali ho attinto le notizie, che sono loro per dare. E siccome da esse anche risulta, che tutti quelli che scrissero finora del B. Alberto, ad eccezione, ch’io mi sappia, di un solo, e non seguìto da alcuno, sbagliarono i calcoli intorno al tempo, in cui visse, così ho trovato ancor necessario di premettere ad esse l’esame delle varie opinioni, che corsero fino a noi, intorno all’anno della morte del nostro Beato, per disgombrarmi così dinanzi la via a discorrere più speditamente da poi, e senza impaccio, delle sue azioni.
Tre sono le principali opinioni, clic corsero finora intorno al tempo, in cui visse il B. Alberto: le due prime sostenuto per conghiettura da due dotti e giudiziosi scrittori, il venerabile Carlo Bescapè, Vescovo di Novara, e il Conte Giorgio Giulini; e la terza proposta senza veruna discussione dalla maggior parte di quelli, che ne scrissero più diffusamente la vita.
Il Bescapè ne` suoi Frammenti della Storia di Milano pubblicati nel 1628, dal culto, di cui godevano ab immemorabili nella diocesi di Milano alcuni santi, tra i quali ripone anche il nostro Alberto, argomentò saviamente dover essere questo vissuto prima del decreto di papa Alessandro III, morto nel 1181, od almeno prima della sesta compilazione delle Decretali, circa I’anno 1235, di papa Gregorio IX, nella quale fu pubblicalo quel decreto, che levava ai metropolitani il diritto della canonizzazione dei Santi, riservandola esclusivamente alla Santa Sede.
Il Giulini all`incontro, nelle sue Memorie della città e della campagna di Milano, stampate I’anno 1706 e seguenti (Parte VII, pag. 504-506), osservando che presso quel tempio di Santa Caterina del Sasso era altre volte un monastero appartenente ai monaci dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus, e che I`origine di quest’ordine si attribuisce a tre nobili cittadini milanesi, Alessandro Crivelli, Alberto Besozzi e Antonio Pietrasanta, così argomentò: «Se il B. Alberto Besozzo di cui si venerano le reliquie, e si onora lo speco presso la chiesa di Santa Caterina, che già era dei monaci di Sent`Ambrogio ad Nemus, è lo stesso, che annoverasi tra i fondatori della sopraddetta Religione, come è assai verisimile, egli certamente visse dopo i tempi, de` quali ora trattiamo.(1)
Infatti la Bolla di papa Gregorio XI, che approva l’ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus, è dell’anno 1375, e da quella si comprende chiaramente, che l’ordine fu stabilito in quel tempo. Abbiamo anche altri esempi tra i Regolari di Beati, che sono stati canonizzati dalla Chiesa, quantunque sieno morti dopo il decreto di Alessandro III e la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX; per la qual cosa se il Bescapè avesse credulo che il B. Alberto da Besozzo fosse stato religioso, come per le addotte ragioni sembra molto probabile, non lo avrebbe annoverato tra gli altri Santi, nei quali la sua conghiettura ha tutta la forza». Così il Giulini.
Media tra queste è I’opinione seguita pacificamente dagli altri scrittori della vita del nostro Beato, i quali ne fissano l`epoca, poco più poco meno, entro la prima metà del secolo XIV, di maniera che niuna delle due surriferite opinioni, nè anco approssimativamente, potrebbe accomodarsi ai loro calcoli. Difatti il Vagliano nella Vita del Beato Alberto ( Milano, 1704 in 24.°) lo dice nato nel 1290 e morto nel 1350, e l’autore anonimo delle Notizie storiche intorno al Beato Alberto ed al Santuario di Santa Caterina del Sasso (Milano, 1845, in 16.°), pone la nascita di lui l`anno 1316, e la sua morte l`anno 1359. Lo stesso aveano detto i più antichi, come un Pietro Galesini, che ne pubblicò la vita in Pavia l’anno 1601, e il P. Annibale Besozzi della Congregazione di S. Carlo Borromeo, il quale nel suo Compendio della vita del Beato Alberto, che io vidi manoscritto nell’archivio prepositurale di Legiuno, Io dice morto parimente l’anno 1359. Dicasi il medesimo del Ferrari, che ne registra la vita nel suo Catalogo dei Santi d’Italia (Milano, 1613, in 4.°), per tacere del P. Paolo Morigia Gesuato nel Santuario della città e diocesi di Milano (ivi, 1603, in 8.°), del Bombognini nell`Antiquario della diocesi di Milano (ivi, 1790. Qui si cita l’edizione II.° del 1828), e di altri, che si accontentarono di dirlo fiorito verso l`anno 1316 o 1319, senza curarsi più avanti degli anni della sua nascita o della sua morte; e per tacere del P. Francesco Maria Guazzo dell’Ordine di Sant’Ambrogio, il quale nella Vita del Beato Alberto (Milano, 1625, in 4.°), dopo di averlo fatto fiorire verso l’anno 1316 sotto il pontificato di Giovanni XXII, lo fa poi morire sotto quello di Niccolò V, l’anno 1450!(2)
Queste sono le principali sentenze degli scrittori intorno al tempo, in cui visse e morì il Beato Alberto. Ora quale tra esse merita di essere abbracciala e seguita? Prima di rispondere mi fia permesso di esporre un’osservazione, la quale ci porrà più facilmente in via alla soluzione del quesito.
Tutti quanti gli scrittori da me citati, ed altri ancora che citerò appresso, avvegnachè discordi su questo punto cronologico, concordano però mirabilmente tra loro nella narrazione dei fatti, e nell’ordine secondo il quale ebbero luogo. Questo mi fece supporre una fonte comune, alla quale essi tutti avessero attinto: e la mia supposizione si cangiò in certezza, quando ebbi in mano quello stesso documento manoscritto al quale essi provocano i loro lettori. Prima di farne parola, non sia discaro anche ai miei, che io qui riferisca i passi principali degli autori suddetti, nei quali si fa menzione di quel manoscritto.
Il P. Annibale Besozzi, esposto un tratto della vita del Beato Alberto colle parole medesime di un antico scritto, soggiunge: «Cosi leggo in un vecchio tarlato libro manoscritto, che si conserva nell’archivio dei RR. PP. Riformati di Sant’Ambrogio ad Nemus, in Porta Comasina a Milano, che fu scritto nell’anno 1318.»
Il Morigia nella sua Storia del Lago Maggiore ( Milano, 1603, p. 192), parlando del Santuario di Santa Caterina del Sasso, scrive egualmente: “Chi vuol avere più piena informazione di questo Beato, legga un`opera stampata in Milano per Michel Tini I’anno 1593, sotto nome della madre Ottavia Besozza, la quale (opera) fu trovata dal signor Antonio Giorgio Besozzi, ed esso la tradusse dal latino in volgare, e con la lode del B. Carlo Borromeo la mandò poi alle stampe.» -- E più esplicitamente ancora il medesimo nella Storia di Milano (Venezia, 1592, p. 434) così avea parlato di quell’antico manoscritto: «La vita di questo Beato fu tradotta in volgare dal nobile Antonio Giorgio Besozzi, dottor leggista, col consenso di Carlo Cardinal Borromeo, avendola cavata da un libro vecchio scritto in carta pecora, che stava riposto presso quei Padri Ambrogiani di Santa Caterina».(3)
La stessa cosa viene confermata dal Galesini, dichiarando di aver tratte le notizie intorno al Beato Alberto dai monumenti, ch’esistevano nella Chiesa di Santa Caterina presso i Padri suddetti. Ma più grave e autorevole di tutte, anche perciò che diremo, è la testimonianza del venerabile Bescapè nei frammenti citati. «Abbiamo veduto, dice, un libro manoscritto, nel quale si discorre più compiutamente di questo Beato. Quel libro fu tradotto in lingua volgare dal giureconsulto Antonio Giorgio Besozzi, e mandato alle stampe».
Da queste testimonianze si può raccogliere:
I. Che le notizie principali della vita del Beato Alberto furono già scritte originariamente in latino, e poi circa un tre secoli dopo tradotte in volgare e pubblicate per le stampe. Dal che si scorge come, ammesso questo fatto, vada da per sé a cadere la conghiettura del conte Giulini, il quale, ignaro di questo scritto, fu costretto di argomentare su altri dati posteriori, che ora sono trovati erronei, come mostreremo ben presto.
II. Che quell’antico manoscritto, tuttoché base e fonte comune, a cui quegli scrittori attinsero le notizie intorno al Beato Alberto, era però mancante di sufficienti dati cronologici per istabilire il tempo in cui egli visse e morì: con che si spiega per l`una parte la concordia loro nella narrazione dei fatti, e per l’altra la loro discrepanza sopra quel punto cronologico, discrepanza in essi cagionata dall’aver preso la data del tempo, in cui fu scritto quel libro, per quella del tempo, in cui visse il Beato, come si renderà chiaro dal processo del nostro ragionamento.
Premesse queste notizie, entriamo ora a parlare di quell’antico manoscritto, che ci conservò le memorie più autentiche del Beato Alberto, e dal quale possiamo con tutta sicurezza fissare il secolo, entro il quale egli visse, ciò che forma appunto lo Scopo delle nostre ricerche.
Due copie di esso manoscritto, l’una in latino, e l’altra in volgare, mi vennero di questi giorni comunicate. La prima esiste nell`archivio prepositurale di Legiuno col seguente titolo: lnitium cultus ct celebrationis Ecclesiae sanctae Catharinae ad Saxum Balarum, MCCCXIX.(4) L’altra copia in volgare, da me fedelmente trascritta, esiste presso il teologo don Pietro Guglielmazzi di Pallanza. Questa secondi apparteneva al venerabile Bescapè, e dopo la sua morte rimase insieme con altri suoi manoscritti presso i RR. PP. Barnabiti di Novara, dai quali ebbela il teologo sunnominato. È una breve scrittura in carta comune col seguente titolo: Narrazione del principio della devozione di Santa Caterina del Sasso Ballaro, 1319.
Dal confronto di questa copia volgare coll’altra latina, mi accorsi tosto che la prima è una traduzione letterale di questa, e dalla quale perciò mi varrò in appresso por maggiore comodità de’ miei lettori. Questa traduzione ha inoltre due vantaggi sopra la copia latina, il primo de’ quali è che fu sottoscritta ed approvata per le stampe dal Beato Alessandro Sauli a nome di S. Carlo Borromeo, culle seguenti parole: Ego Alexander Saulius sacrae theologiae doctor nomine Ill. et Rev. Cardinalis Borromaei Archiepiscopi Mediolani et R. Patris inquistoris violi hoc opus et tanquam pium, nihilque orthodoxae fidei repugnans approbavi.(5)
L’essere stata trovata questa traduzione appresso il venerabile Bescapè, e più l’essere stata sottoscritta e approvata dal Beato Alessandro Sauli per ordine di San Carlo, mi fanno credere essere la stessa, che fu fatta dal giureconsulto Antonio Giorgio Besozzi, come di sopra fu detto. Dico «mi fanno credere,» giacché per quante indagini abbia fatte, non mi venne mai di poter avere notizia alcuna di quell’edizione.(*)
L’altro vantaggio di questa traduzione sopra l’originale latino è quello di offerirci in fine e immediatamente prima della detta sottoscrizione, una notizia, che non poteva trovarsi nella copia latina, ed è la seguente: «A tempi nostri il detto corpo è stato posto nella cappella di Santa Caterina, ove si può vedere.» Questa breve notizia nell’atto stesso che si riconosce come un aggiunta fatta all’antico manoscritto, serve anche di prova che il corpo del Beato Alberto non era mai stato levato dal suo primo sepolcro fino a quel tempo, cioè sino all’anno 1535, come vedremo.
Che poi il nostro manoscritto latino sia una copia di quello stesso che fu veduto e citato dagli autori sopra allegati, è manifesto dal confronto dall’esposizione fatta da essi delle geste principali del Beato Alberto coll’esposizione che trovasi nel manoscritto. Acciocchè i lettori sieno in grado d’istituire da sè questo confronto ed anche per l’importanza del documento medesimo, esso sarà da me fedelmente riferito per intero o nel resto o nelle note, secondo che meglio cadrà in acconcio. Una sola difficoltà potrebbe muoversi, a primo aspetto anche speciosa, intorno all’anno in cui fu scritto (6).
Abbiamo detto che gli autori, che provocano ad esso manoscritto, presero l’anno 1319 non per quello in cui fu scritto quel libro, ma per l’anno generalmente parlando della conversione del Beato Alberto, morto secondo alcuni di loro l’anno 1350, secondo altri l’anno 1359. Importa dunque assaissimo al nostro scopo di segnalare un così grave abbaglio preso da essi; e non è difficile il farlo. Vero è che gli autori citati quando parlano di quel libro antico, non dicono però in qual anno fosse stato composto, se si eccettui il P. Annibale Besozzi, che lo dice scritto nel 1318, cadendo poi in contraddizione con sè medesimo: ma ch’esso sia scritto in quest’anno 1318, ovvero l`anno seguente 1319, come portano la copia latina e la volgare che abbiamo avute sott’occhio, si rileva dai fatti in esso libro narrati e da altri documenti, che li confermano. Entriamo dunque tosto ad esaminar questi fatti sul libro stesso.
Esso è diviso in diciassette brevissimi capitoli, il primo de’ quali serve di preambolo alla narrazione, i nove seguenti contengono la vita del Beato Alberto, e gli altri sette i successivi incrementi del Santuario di Santa Caterina. Siccome dal preambolo può ricavarsi qualche notizia sull’origine del libro e sull’autore di esso, gioverà riportarlo. -- «Essendo io desideroso, così incomincia il nostro manoscritto, di sapere come avesse principio la Chiesa e l’indulgenza, che per bontà divina è posta nel Sasso Balano, ne domandai con grande istanza ad uno di quei Padri, quale conoscevo a vista, ma non so il nome, dal quale per grazia e dono d’Iddio intesi esser vero quello che ora racconterò.
E maggior fede mi lare, che dar si debba a quello che dirò, conciossiacosa che colui che mi narrò questa historia, era di età provetto ed abitator del medesimo luogo per fin da puerizia, e ivi servendo con purità Iddio, sempre si affaticò dalli più vecchi con diligenza intendere lutto quello che pareva più conveniente per la chiarezza di questo fatto. Il principio del suo ragionamento fu a questo modo.» E qui finisce il capo I e segue il II.
Da questa breve introduzione si raccoglie che la sostanza dei fatti della Vita del Beato Alberto fu narrata da uno di que’ medesimi frati, che dimorava nel convento di Santa Caterina, e pienamente informato di ogni cosa per le ragioni ivi addotte. Onde noi pure crediamo che meriti tutta la fede, tanfo più che, come risulterà anche dal nostro esame, visse circa un secolo dopo la morte del Beato Alberto, per cui potè averne notizie da alcuno, che fosse stato ad esso contemporaneo.
Al preambolo seguono i nove capitoli, nei quali è distribuita la Vita del Beato, indi gli altri sette, che raccontano la storia del Santuario coll’ordine seguente:
CAPO XI. Frequenza dei popoli al Santuario di Santa Caterina.
— XII. Fabbrica della chiesa di Santa Maria.
— XIII. Fabbrica del convento dei Frati Predicatori.
— XIV. Fabbrica della chiesa di S. Nicolao.
— XV. Tentativi falliti per ingrandire la chiesa di Santa Caterina.
— XVI. Mutazione dell’Ordine dei Domenicani in quello degli Ambrosiani.
— XVII. Ricerca fatta del corpo del B. Alberto.
Questo è l’ultimo capitolo che termina collo seguenti parole: «E così finora riman sepolto nel medesimo luogo, e la devozione di giorno in giorno cresce per la grazia di nostro Signore GESÙ CRISTO, Creatore del tutto, che con il Padre e Spirito Santo regna in sempiterno; al quale Figliuolo della intemerata Vergine e Madre sia sempre onore e gloria, e così sia. » A queste parole seguono le altre poche riferite di sopra colla sottoscrizione del Beato Alessandro, che mancano nella copia latina.
Percorso con diligenza questo libro, ho potuto conoscere che ad eccezione dell’anno 1319, che si legge a principio, non s`incontra in esso altra data di tempo determinato, che perciò ci si rendono necessarii altri documenti per venire a capo delle nostre indagini.
Si racconta in esso al Capo XII che furono chiamati ad abitare il convento di Santa Caterina i frati Predicatori, e nel XVI che ad essi furono sostituiti gli Ambrosiani. Vediamo se possiamo accertare il tempo nel quale è avvenuta questa sostituzione.
Nell’archivio prepositurale di Legiuno, oltre alle copie latine del nostro documento, esiste una lunga serie di istromenti in pergamena incominciando dall`anno 1301 sino all`anno 1457. Risulta da questi istromenti, che i monaci dell’Ordine di Sant’Ambrogio abitavano da oltre un secolo in quel convento: risulta di più che sino dall`anno 1314 vi era già priore di quel convento certo Gaspare de Rogiatis, appartenente a qual’Ordine. Ora con questo documento alla mano possiamo con tutta sicurezza asserire, che i Domenicani al più tardi rimasero in quel convento sino all`anno 1314. Fissato quast’anno, andiamo innanzi, e procuriamo d’investigare in qual anno, almeno approssimativamente vi poterono essere stati chiamali.
Dalle testimonianze recate dal conte Giulini nelle sue Memorie di Milano (P. VII, p. 336, 346, 356 e P. IX, p. 85-86) è chiaro che S. Domenico fu in Milano circa l’anno 1220 per ben due volte, e che alquanti anni dopo, cioè intorno all’anno 1227, i suoi vi si stabilirono presso la Chiesa di Sant’Eustorgio, che anche fu loro ceduta insieme coll’annessa canonica. Perché poi i Domenicani potessero quivi crescere e propagarsi a tal segno da mandarne alcuni anche al nuovo convento di Santa Caterina, è necessario supporre, che passasse lo spazio almeno di 10 o 15 anni, che aggiunti all’anno 1227, ci porterebbe a stabilire la loro venuta in quel convento tra gli anni 1237 o 1240, all’incirca.
La dimora dunque dei Domenicani nel convento di Santa Caterina si può convenientemente fissare entro gli anni 1235 e 1314 pel corso di circa ottant’anni al più. Ora risaliamo di nuovo sino alla fabbrica della Chiesa di Santa Caterina, trovata l’epoca della quale, avremo trovato approssimativamente anche l’anno della morte del Beato Alberto.
Racconta il nostro manoscritto, che la Chiesa di Santa Maria coll’annesso Convento fabbricatovi poco dopo, fu edificata dai popoli vicini al Lago Maggiore in occasione di una seconda pestilenza avvenuta in quei luoghi. Non dice, è vero, in qual anno ciò succedesse, ma da una espressione che usa, possiamo facilmente argomentarlo. Ecco le sue parole: «Ricordatisi gli uomini dei doni e grazie antiche, che in quel luogo avevano ricevute, andarono con prieghi e voti piangendo al detto luogo.» Riflettiamo, perchè si potessero chiamare antiche le grazie ivi ricevute, è necessario certo supporre un periodo alquanto lungo di tempo, passato tra l’una pestilenza, che diede occasione alla fabbrica della prima Chiesa (ch’è quella di Santa Caterina) e l’altra, che fu occasione della fabbrica eletta Chiesa di Santa Maria. Poniamo corsi tra l’una e l`altra fabbrica dai trenta ai quarant`anni. Leviamoli ora dagli anni, che abbiamo stabiliti per la venuta dei Padri Domenicani in quel convento, e ci troveremo alla fine del secolo XII, cioè verso l`anno 1200 dell’era nostra; ci troveremo cioè all’epoca approssimativa della morte del Beato Alberto, che avvenne appunto poco dopo la fabbrica del Santuario di Santa Caterina.
Chiunque ha tenuto dietro a questo calcolo semplicissimo si persuaderà facilmente, che la Vita del Beato Alberto dovrà quindi innanzi collocarsi entro il secolo XII, e la sua morte al più tardi al principio del seguente. Io però inclino a crederlo morto tra gli anni 1187 e 1195, nei quali si fa menzione dagli storici di una pestilenza in queste nostre contrade. Ma su di ciò, come anche per ogni altra questione particolare, rimetto il lettore al processo del nostro racconto: dal quale inoltre risulteranno altre prove irrefragabili di questo calcolo, per istabilire il quale non abbiamo voluto per ora servirci principalmente che di un solo documento.
Concludiamo pertanto che da tutto questo si rende manifesta la falsità delle date cronologiche degli scrittori della Vita del nostro Beato, e inammissibile la conghiettura del conte Giulini, mentre quella del venerabile Bescapè vi riceve anzi una luminosa conferma. E ciò sia detto per amore del vero, al quale da ultimo deve servire ogni cosa.
(1) Cioè dopo l’anno 1235.
(2) Questi ed altri errori cronologici del Guazzo furono già notati dai Bollandisti nella Vita del B. Alberto sotto il giorno 3 di settembre. Eppure il Guazzo fu monaco ambrosiano ed abitò nel nostro convento di Santa Caterina, ove esistevano tutti i documenti, dei quali noi siamo costretti di servirci per confutarlo!
(3) La prima edizione della vita del B. Alberto scritta dal detto Antonio Giorgio Besozzo, è come ho detto, dell`anno 1593, e fu dedicata alla Serenissima Infanta Caterina Duchessa di Savoia, sotto il nome di Ottavia Besozza sorella di Antonio Giorgio. La seconda è dell`anno 1606, in 16 pure in Milano e fu dedicata al Sacerdote P. Dionisio Besozzi, frate Cappuccino.
(4) Nello stesso archivio si trovano due altre copie di questo documento, posteriori alla prima, ma collo sbaglio dell’anno 1419 in luogo dell`altro 1319, come ivi si legge. È però da notare che questa data pure si leggeva in una di esse copie, ma fu corretta nell’altra 1419 dallo stesso trascrittore o da altra mano, forse perché trovata in contradizione colle date cronologiche delle Vite del Beato già stampate; la qual cosa serve anzi a confermare viemeglio l`antica data. Noterò ancora che una di esse copie fu trascritta da Fr. Vito da Mombello il 3 novembre 1796, con questo avvertimento: «Copia sincera di ms. esistente appresso il Sig. Canonico Giovanni Antonio Cerutti, residente a Santa Caterina del Sasso Ballaro, e ricopiata dal ms. che sta nell`archivio prepositurale di Legiuno.»
(5) Il B. Alessandro Sauli omise la data della sua approvazione, ma possiamo approssimativamente restringerla entro gli anni 1567 e 1570, nel corso de’ quali egli, eletto Generale dell’Ordine de’ Barnabiti, ai quali apparteneva, rimase in Milano consigliere, aiutatore e quasi collega di S. Carlo nella riforma di quella diocesi. Vedi Gallizia, Vita del B. Alessandro Sauli. Ho poi veduto anche un’altra copia della detta Narrazione, nella quale alla approvazione del B. Sauli si soggiunse la seguente del ven. Bescapè: Carolus a Basilica Petri Praepostlus generalis clerc. reg. S. Pauli decollati iudico imprimi posse historiam hanc ut piam, cum praesertim et veterem Latinam viderim, unde et scripta est et conversa, et subscriptionem quoque suprascripti Reverendissimi D. Alexandri Saulii nunc episcopi Aleriensis autenticam inspexerim.
(*) Così scriveva l`anno 1856. Ho poi vedute le due edizioni fatte di questa Vita, come ho riferito nella nota aggiunta alla pag. 39. La seconda di queste edizioni fu citata anche dal Picinelli nel suo Ateneo de’ letterati Milanesi, Milano, 1670, in 4.° alla pag. 45.
(6) Dai passi dei varii Autori, che citano il ms. latino, risulta che di esso esistevano due esemplari, l’uno presso i PP. RR. di Sant’Ambrogio in Milano, scritto nel 1318, come scrive il P. Annibale Besozzi, l’altro scritto nel 1319, esistente presso i PP. di Santa Caterina del Sasso. Che poi l’uno di questi concordasse perfettamente coll`altro, si ha dal confronto dei passi che sono riportati dagli scrittori della Vita del Beato, dei quali passi basterà qui nominare quello, che è riferito dal suddetto P. Annibale sull’esemplare del 1318, che si trova identico a quello che è nella copia del 1319. Chi volesse farne il confronto, incomincia così: Deus illum solatio visionis angelicae, etc.
(7) Nessuno degli autori da me veduti, se si eccettui il Vagliano, ricorda positivamente il nome della patria del nostro Beato. Alcuni Io dicono da Besozzo o de’ Besozzi o semplicemente Besozzo, nelle quali espressioni v’ha un`allusione alla famiglia, a cui apparteneva, ed alla originaria provenienza di essa, ma non ci assicura del luogo natale. Altri si accontentano di dirlo senz’altro milanese, e v’ha pur arco chi Io dice accasato in Milano. Difatti nella parete interna della cappella di Santa Caterina si leggono tuttora queste parole: Hic quiescit corpus B. Alberti Besutii Mediolanensis fundatoris istius aedis, che vi furono scritte verso la metà del secolo XVII. Ma più probabile mi pare la tradizione riferita dal Morigia nella sua Storia del Lago Maggiore (pag. 190), là dove dice: «In Arolo v’è un ceppo nobile di casa Besozza, tutt’uno con quello di Moallo, dal quale si tiene che uscisse il B. Alberto.»
Questa tradizione è confermata pure dal racconto di Antonio Giorgio Besozzi presso il Vagliano (Rive del Verbano, Milano, 1710, pag. 340), che scrive: «Antonio Giorgio Besozzi ritrovò nel Cenobio di Santa Caterina nel 1603 antica scrittura senza millesimo, che diceva come il B. Alberto Besozzi fosse dello stesso ceppo di un altro Alberto Besozzi, che fu dottore nel Collegio di Milano, il quale aveva casa da Nobile ed effetti nei luogo di Arolo, de’ quali sono rimasti eredi, per ragione di fidecomisso, i medesimi signori conti Guilizoni.»
Dell’esistenza poi della famiglia Besozzi in Moallo (o Movallo o Monvalle, come anche si chiama) e in Arolo, sino da tempi remotissimi, non v’ha alcun dubbio. Nel primo di questi luoghi rimase estinta circa un mezzo secolo fa, nel secondo ancora sussiste ab immemorabili. L`oratorio dedicato a S. Pietro martire in Arolo vi fu edificato da questa famiglia, e fu dalla stessa fatto dipingere nel 1412, come ivi ancora si legge. Del resto che a que’ tempi famiglie anche nobilissime abitassero nei borghi o nelle castella e terre della campagna di Milano, ove tenevano i loro possedimenti non è maraviglia. Il solo Giulini ce ne offre parecchi esempi.- Autore:
- [Vincenzo De Vit]
- A Cura di:
- [Riccardo Papini]
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
Magazzeno Storico Verbanese
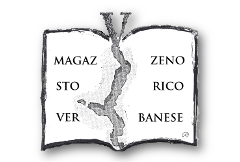 A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.Biografia Carlo Alessandro Pisoni
Carlo Alessandro Pisoni (Luino, 1962 - Varese, 2021). Seguendo le orme del padre Pier Giacomo, dal 1991 al 2017 è stato conservatore, per gentile concessione dei principi Borromeo, dell'Archivio Borromeo dell'Isola Bella. Appassionato studioso e ricercatore, ha sempre voluto mettere a disposizione degli altri conoscenze e scoperte, togliendo la polvere dai fatti che riguardano Lago Maggiore e dintorni; insieme a studiosi e amici, ha riportato alla luce tradizioni, eventi e personaggi passati dal lago, condividendoli con la sua gente.
