STRUMENTI CULTURALI
del Magazzeno Storico Verbanese
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
- Nominativo:
- Besozzi, Nicone
- Descrizione Personaggio:
- Santo eremita, venerato a Besozzo
- Luogo e Data di Nascita:
- [...], floruit 1300 [...]
- Luogo e Data di Morte:
- Besozzo, floruit 1300 [...]
- Testo completo:
- APPENDICE
MEMORIE DI S. NICONE EREMITA
DI BESOZZO
Nelle ricerche da me fatte intorno alla vita del beato Alberto ebbi occasione di segnalare in parecehi di quegli scrittori, che ho consultato, oltre ai notati sin qui, degli altri errori grossolani in fatto di cronologia e di storia, specialmenie intorno ad alcuni individui della famiglia, alla quale apparteneva il nostro Beato. Per non aggravare di troppe note la vita di questo, volendo dilucidare ogni cosa, ho creduto prezzo dell’opera, anche per aiutare coloro che vorranno dope di me trattare pia diffusamente questo argomento, soggiungere in apposita appendiee quelle poche memorie di s. Nicone, che reputo genuine, espurgandole in pari tempo dagli errori più gravi, de’ quali furono sino ai nostri giorni imbrattate. Spero con ciò di far cosa grata agli amatori della storia, prima dote della quale deve essere senza dubbio la verità.
E certo stando alla testimonianza della maggior parte di quelli che scrissero del beato Alberto, anche s. Nico o Nicone, ovvero Nicolò, come pure viene chiamato, sarebbe da annoverarsi fra gli antenati illustri per santità della famiglia Besozzi. Io però confesso di non avere sufficienti documenti per appoggiare od infermare questa asserzione, ché del resto, anche senza di lui, la famiglia Besozzi rimane e rimarrà egualmente cospicua nella memoria dei posteri per altri personaggi insigni per bontà di vita e santità non comune, e de’ quali si ha tutta la certezza, che indubitatamente le appartennero.1
Due vite particolari ho veduto di s. Nicone, l’una scritta da Giangiacomo Besozzo con questo titolo: Compendio della vita del sant’anacoreta Nicone Besozzo (Milano, 1699 in 4to, di pagine 28) e l’altra scritta da un canonico della chiesa collegiata di Besozzo col titolo Atti di s. Nicone Besozzi, religioso, sacerdote e anacoreta, tutelare del borgo nobilissimo di Besozzo (Milano, 1758, in 8vo, di pagine 34). Questo secondo trascrisse alla lettera gli errori del primo, aggiungendovene ancora degli altri, come quello di averlo fatto sacerdote. Ecco in breve che cosa essi raccontano di s. Nicone.
«Nicone nacque l’anno 350 nella terra di Barasso, non molto lungi dal borgo di Besozzo, di Alessandro Besozzo (fratello di Barnaba, padre del b. Alberto Besozzo, fondatore dell’insigne religione di Sant’Ambrogio al Nemo) e di Maddalena Borri, della famiglia di s. Mona, quarto arcivescovo di Milano.2 Orbato dei genitori in età molto tenera, fu condotto a Milano, dove fu ammesso alla visita di sant’Ambrogio. Allora Milano era travagliata dall’eresia degli Ariani. Nicone si associò con sant’Ambrogio contro di essi, e fu allora, che debellando gli Ariani apprese il modo di vincer sé stesso, e risolvette di non più vivere al mondo, ma di ritirarsi in una soitudine. Abbracciò quindi la Religione Ambrosiana non molto prima fondata dal b. Alberto Besozzo e compagni, suoi affini. Pochi anni appresso chiese ed ottenne licenza dai superiori del Monastero di ritirarsi in un qualche eremo per vivere vita solitaria e penitente giusta la consuetudine di molti in quei tempi. Si portò quindi presso Besozzo sopra un cone allora incolto, dove si fabbricò una cella, o meglio una grotta, entro la quale visse in rigidissima penitenza, e dove morì in età di 83 anni il dì 18 di aprile dell’anno 433».
Tali sono in sostanza le cose che raccontano quegli scrittori intorno a s. Nicone. È facile vedere come tutto quello che si riferisce al tempo in cui visse, ed al genere di vita da lui abbracciato a principio, deve parere ad ognuno per lo meno molto dubbioso, ed a chi si conosce alquanto di storia anche falso, perciò non ispenderò molte parole nel confutare siffatti errori.
Racconta il Morigia nella sua Storia degli Ordini Religiosi e in quella di Milano (pag. 434), che un b. Alberto Besozzi, cui distingue dal nostro col titolo di seniore, insieme con altri due nobili cittadini milanesi Alessandro Crivelli e Antonio Pietrasanta, fosse il fondatore ai tempi di sant’Ambrogio dell’ ordine dei frati chiamati di Sant’Ambrogio al Nemo. «Questi tre compagni, egli dice, menavano l’anno 380 vita solinga fuori di porta Comasca, in un bosco, dove fu poi fabbricata una chiesa al nome del protettore Sant’Ambrogio al Nemo, detto dal luogo Andemo, ed erano spesso visitati da sant’Ambrogio con gran carità». Ecco l’autorità principale, alla quale si appoggiano gli scrittori citati; ma che questo sia stato un sogno del buon Morigia, sulla fede del quale venne anche spacciato da altri non solo esteri, rna pur milanesi, è ora da tutti universalmente tenuto.3
Causa precipua dell’errore del Morigia sembra che sia stato un passo di sant’Agostino, dal quale si viene in cognizione che al tempo di sant’ Ambrogio vi era già in Milano fuori delle mura della città un monastero d’uomini sotto la direzione di questo Santo Dottore.4 Per quanto sia certo questo fatto, non possiamo però da esso argomentare con sicurezza che il luogo designato da sant’Agostino sia quello appunto che fu poi chiamato il Bosco di Sant’Ambrogio; e dato pure che fosse lo stesso, né anche per questo potremo dire che i monaci di Sant’Ambrogio al Nemo fossero per interrotta successione que’ medesimi frati che vivevano al tempo di s. Ambrogio.
Abbiamo già veduto di sopra che niuna traccia di essi vi rimaneva nell’undecimo secolo; ed è d’altra parte cosa notissima, per non dir di più, che le famiglie Crivelli, Pietrasanta, e Besozzo, alle quali appartenevano i fondatori di quell’ordine, non potevano cosi denominarsi nel IV secolo dell’era nostra, ritenendosi omai da tutti come indubitato che i nostri cognomi ebbero origine nell’XI secolo. Per cui è giuoco forza conchiudere, che se s. Nicone fu religioso ambrosiano, non potè esserlo che nei primordii di quella Religione, e al più presto possibile nel XII secolo.
Ora che s. Nicone sin appunto vissuto in questo secolo e non ai tempi di sant’Ambrogio, è manifesto dalla testimonianza di uno scrittore solo di un sccolo posteriore, cioe di quel Gotofredo da Bussero, ricordato di sopra. Questo negli Atti dei Santi della diocesi di Milano così ci lasciò scriito di lui: «V’ha nel luogo di Besozzo, diocesi di Milano, la chiesa del Venerabile Nicolao confessore. Questo fu un laico del luogo di Gomero (ora Comerio), il quale morì intorno all’anno del Signore MCLXXX il giorno XIII avanti le calende di maggio, cioè il 19 di aprile.5
Ammessa una volta la verità di questo racconto, cadono a terra tutti gli altri supposti dai nostri autori. Che dovrà dunque dirsi di quel Beato Alberto, il seniore, cugino di s. Nicone, e fondatore dogli Ambrosiani? Io confesso di non saperne dir nulla, e sono forte tentato a crederlo una cosa stessa col nostro b. Alberto, anzi dirò che se v’ha qualche cosa di vero nella tradizione surriferita della parentela di s. Nicone col b. Alberto, credo che sia la coincidenza dell’età, in cui vissero entrambi, e del genere medesimo di vita, ch’essi condussero. E per questo io porto anche opinione che il nostro b. Alberto sia stato da prima creduto fondatore degli Ambrosiani, perché si volevano o si credevano del tempo di Sant’Ambrogio; ma che essendosi da poi scoperlo non essere questo vissuto ai tempi di Sant’Ambrogio, e non volendosi pure abbandonar quell’errore, sia stato distinto da un altro del medesimo nome, e così di un solo individuo si sieno fatte due persone diverse.6.
Ma tornando al nostro santo, è da dire, che secondo la testimonianza di Gotofredo lasciando anche correre che fosse laico religioso, non si dovrà poi più ritenere per sacerdote, tuttoché l’urna, entro la quale si vencrano ora le sue sacre reliquie, cel presenti vestito con abiti sacerdotali. E certo niun indizio di questo ci danno le vecchie imagini sotto le quali veniva effigiato: «Le più antiche imagini di s. Nicone, dice il Giulini, lo rappresentano in abito da eremita con una fune intorno ai fianchi, alcune in atto di recitar la corona, ed altre, che sono certatnente le più vecchie, con una croce in mano». Lo stesso Giulini anche osserva, ch la conghiettura fatta dal venerabile Bescapè intorno al tempo in cui visse s. Nicone, riceve dal passo di Gotofredo una bella conferma.
Da tutto questo possiamo conchiudere, che delle cose narrate dagli scrittori sul conto di s. Nicone, questo solo può aversi per certo, che fu un eremita, che visse santamente nel duodecimo secolo sopra il colle presso Besozzo, dove alcun tempo dopo la sua morte fu edificata una chiesa in onore di lui. Questa chicsa fu recentemente ristaurata e ingrandita dalla devozione dei popoli vicini, che accorrono a venerarne le sacre spoglie, e specialmente degli abitanti di Besozzo, che si gloriano di averlo per loro principale patrono.
Quanto poi al culto, di cui gode ab iminemorabili il nostro santo nella diocesi di Milano, esso è fuori di ogni dubbio. Oltre alle citate, ne abbiamo altre testimonianze, che non patiscono veruna eccezione, basti per tutte la ricognizione che fece delle sue reliquie s. Carlo nell’anno 1575.* A proposito del quale racconta il Bosca, che il corpo di s. Nicone, cui il Santo Arcivescovo aveva rinchiuso entro l’altare, fu di poi per concessione del card. arcivescovo Federico Visconti riposto in un’altra arca bellissima e riccamente lavorata, e con solenni supplicazioni collocato sopra l’altare ai 29 di aprile dell’ anno 1685.7
Tali sono lo memorie che ho potuto accertare intorno a questo santo. Con esse pongo termine alla presente operetta sopra il b. Alberto Besozzi e il Santuario di Santa Caterina del Sasso. L’amore della verità ha presieduto a questo lavoro, e siccome per esso ho corretto con libertà gli errori altrui, così per esso egualmente godrò di emendare me stesso, se alcuno, ove trovi ch’io pure sia caduto in errore, si compiacerà di avvertirmi, persuaso che questo sia l’unico mezzo per giungere in fine ad avere una storia, che possa dirsi, almeno quanto alla sostanza, e per quanta il eonsentano le forze umane, degna di fede.
1 Ne ricorderò alcuni de’ principali: Alberto Vescovo di Cassano nelle Calabrie intorno all’anno 1312: Branchino vescovo di Bergamo intorno all’anno 1380, il quale aveva fondato una collegiata in Monate con arciprete e canonici, che fu poi soppressa da s. Carlo Borromeo; e Giocchino, monaco cisterciense e poi cardinale di Santa Chiesa, eletto nel 1743, e morto in Tivoli l’anno 1755. Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, a cui era assai caro, ne fece trasportare il corpo in Boma e gli fece erigere un monumento con iscrizione nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Ma per santità di vita sopra tutti di questa famiglia sono dagli scrittori ricordati i seguenti. La B. Contessa Besozzi o da Besozzo. Fu abbadessa del Monastero di Meda. Il venerabile Bescapè nei suoi Frammenti citati dal Giulini (P. VIII, p. 8), dove tratta della propria famiglia originaria da un luogo, che fu chiamato Basilica Petri da una chiesa ivi edificata in onor di s. Pietro, fa menzione di una lettera dell’Arcivescovo di Milano, Ottone Visconti, scritta l’anno 1271, nella quale conferma l’elezione di Contessa da Besozzo in badessa del monastero suddetto, coll’assenso di parecchi ordinarii, che dovevano essere esuli, come il loro prelato, e tra gli altri di Alberto da Bescapè o Bascapè (a BASiliCA PEtri). Da ciò si scorge in che tempo vivesse quella Beata Contessa, che secondo il Morigia (Storia del Lago Magg., p. 197), sarebbe fiorita sino dall’Ottocento! Il medesimo scrive, che questa Beata fece fare la traslazione dei corpi dei santi Aimo e Veremondo, e che circa i medesimi tempi (ora sappiamo quali) fiorivano in quello stesso monastero di Meda altre due Besozze di santa vita, cioè donna Galdina e donna Corrada (Vedi Storia di Milano, p. 434). La Beata Felicita Besozzi. Fu Francescana del convento di Santa Maria del Gesù in Milano, ove morì il 30 aprile del 1450, come si legge nel Martirologio Francescano presso il Wadingo negli Annali di quell’ordine. È ricordata pure dal Bosca nelle note al Martirologio Ambrosiano, p. 356. Un B. Giacomo Besozzi ed una suor Teodora Besozzi, morta santamente nel monastero di santa- Maria del Monte sopra Varese, sono ricordati dal Morigia e dal Vagliano nelle opere citate. Di questi non ho trovato altra memoria. * Finalmente il Bombognini nel citato Antiquario (p. 71) ci fa sapere che un Giovanni Besozzi monaco ambrosiano nel 1178, viveva vita eremitica in una cella presso la chiesa di S. Sepolcro in Ternate già fondata fino dall’anno 1148.
Chi volesse avere maggiori notizie sulla famiglia Besozzi legga il Trattato degli Uomini illustri di casa Besozzo del giureconsulto Antonio Giorgio Besozzi; trattato che ho veduto spesso citato, ma che non potei aver mai tra le mani. Soggiungerò ad onore di questo Antonio Giorgio Besozzi, com’egli avesse concertato con papa Gregorio XIII, con s. Carlo Borromeo e col Duca di Savoia, sul modo di formare una milizia cristiana all’estirpazione delle eresie e degli infedeli, e come per questa impresa quel Duca avesse offerto un 50000 scudi. Ma la morte di s. Carlo e di quel pontefice impedirono quel disegno. Questo stesso Besozzi fu autore tra le altre di un’opera intitolata: Discorsi di Filosofia militare, che fu pubblicata dopo la sua morte per cura di Nicolò Pelizzari in Milano 1629, in 4.° — Di altri Besozzi posteriori fanno menzione diverse epigrafi, che si leggono nella Cappella dell’oratorio di S. Nicone, delle quali trascriverò soltanto la seguente, che trovasi alla sinistra della cappella dedicata a S. Antonio di Padova: Ioann. Baptista ex nob. et antiqua Castrobesutiorum familia abbas concistorialis protonotarius apostolicus Argentinae gubernator pro S. Sede, Sacelli huius proprietarius. Obiit anno Domini MDCLXIV, quarto mensis Augusti.
Aggiungerò finalmente, che di un celebre pittore, che fu anche scultore e cronista, spettante a questa stessa famiglia, Leonardo da Besozzo, la cui memoria si era quasi perduta, dettò con amore e assai diligenza un’operetta l’illustre cav. Carlo Morbio, pubblicata in Milano I’anoo 1860 in soli trenta esemplari, non venali. Più tardi il medesimo scrisse nuovamente di questo pittore in altra sua opera, che ha per titolo: Opere storico-numismatiche ecc. , Bologna, 1870, in 8.°, pag. 213 e segg. e più diffusamente ancora in una terza: Francia ed Italia, ossia i manoscritti Francesi delle nostre Biblioteche ecc. Milano, 1873, in 8.° gr., cioè alla pag. XXVI n.° XIII, alla pag. 202-207, e alla pag 231 e seg.
2 Questa Maddalena Borri, che qui si dà per madre di s. Nicone, in vece dal p. Annibale Besozzi (seguito in questo anche dall’autore delle Notizie storiche intorno al b. Alberto), è detta moglie del nostro b. Alberto! Non è poi da stupire che si dica nipote di s. Mona, quarto Arcivescovo di Milano. Nel medio evo e specialmente dal secolo XIV in poi molte nobili famiglie milanesi trovarono scrittori, che ne tesserono le genealogie più lontane e con tutta facilità. Un eroe troiano od un re bellicoso dei tempi antichi erano capostipiti belli e trovati per alcune, ad altre poi bastava anche un santo dei primi secoli della Chiesa. Così la famiglia Visconti discendeva da Anglo nipote di Enea, e fondatore di Angera, chiamata Angleria; la Morigia da un re della Mauritania o de’ Mori, alleato di Giulio Cesare, e la famiglia Litta da s. Lorenzo. Qual meraviglia che anche la Borri, che secondo i documenti recati dal Giulini (agli anni 1132 e 1162), pare di schiatta longobarda, fosse della stessa famiglia di s. Mona? cioè «della schiatta potente di Afranio Borro, celebrato. da Tacito» come tra gli altri ci lasciò scritto anche il Puccinelli (Zodiaco della Chiesa Milanese, Milano, 1650) nella Vita di s. Mona?
3 Ecco come parla il Sassi, scrittore assai giudizioso sul conto del Morigia: Scriptores Mediolanenses aliique exteri (come il Maurolico nel suo Mare Oceano di tutte le Religioni del mondo), secuti narrationem Pauli Morigiae, duos in hac metropoli extitisse l:egolares coetus tradiderunt, alterum eorum, qui Apostolini seu S. Barnabae, appellantur, eo quod institutorem suum fuisse hunc Apostolum, sed falso prorsus, iactabant; alterum quorumdam fratrum ordinis S. Ambrosii ad Nemus nuncupati, pariter citra verum, originem suam ab eo sancto Doctore renditantium (vedi Histor. Mediol. Antist. T. III, p. 826).
4 Erat rnonesterium Mediolani plenum bonis fratribus extra urbis moenia sub Ambrosio nutritore (Sant’Agostino, Confess., lib. VIII, c. 6).
5 Ecclesia venerabilis Nicolai Confessoris est in loco Besutii Mediolanensis dioecesis. Hic LAICUS fuit loci de Gomero. Obiit anno Domini MCLXXX, vel circa id, die tridecima ante kalendas Madii (appresso il Giulini, P. VI, p. 503-504). È da notare che in questi tempi si faceva distinzione tra die tridecima e die decimatertia spiegandosi la prima formula pel giorno 18 aprile e ritenendosi l’altra per indicare il 19. Con ciò si spiega, perchè si celebri presentemente la festa di S. Nicone, non il 19, ma il 18 di aprile. Comerio poi è luogo poco distante da Barasso, donde forse la confusione dell’uno per l’altro. «La terra di Barasso, dice ivi il Giulini, crede di essere stata la sua patria, ed ivi si mostra una casa , che dicesi da lui abitata».
6 Io sono persuaso che in questo errore sia caduto anche il Bosca, il quale nel suo Martirologio Ambrosiano dopo di avere parlato nel giorno 3 di settembre del nostro B. Alberto, nelle annotazioni poi alla pag. 336, ne annovera un altro tra i beati dell’ordine soppresso degli Ambrosiani.
La qual cosa credo anche gli sia occorsa parlando di S. Nicone, cui egli ivi stesso distingue da un altro S. Nicone o Nicolao, cui registra similmente tra i beati del medesimo ordine. Così di due beati, se ne fecero quattro!
Il Gotofredo fioriva verso l’anno 1290. Scrisse gli Atti di tutti Santi che si venerano nella città e diocesi di Milano e vi ha aggiunto le chiese e gli altari a loro dedicati coi nomi dei luoghi dove si trovano.
* Secondo altri nel 1568. S. Carlo in questa occasione prese una reliquia del Santo per collocarla alla sua Metropolitana, dove ancora si conserva : istituì poi in Besozzo al culto di S. Nicone una Confraternita sotto la regola de’ Disciplini, la quale vegliasse alla custodia di sì prezioso tesoro. Questa poi nel 1729, ornò la cappella di pitture e vi pose la seguente iscrizione:S. CAROLUS
AD S. NICONIS CULTUM
CONFRATERNITATEM INSTITUIT
CONFRATERNITAS
IN CULTUS TESTIMONIUM
ORATORIUM PICTURIS ORNAVIT
7 Il Bosca così lo registra nel suo Martirologio: Besutii, sancti Nici heremitae, qui in illo oppido magnam habet venerationem. Nelle annotazioni poi (pag. 88-89) cita un antico Calendario di 300 anni addietro colle seguenti parole: In Calendario acephalo ms. (quod videtur trecentis et amplius abhinc annis exaratum) atque in quodam Indice ms. Galvanei Flammae appellatur Nicolaus, illumque alii vocant Nicum, et alii Niconem. Vedi anche il Morigia, Stor. di Milano, p. 434, e il Giussani nella vita di S. Carlo colle note dell’Oltrocchi. II Bombognini aggiunge, che s. Carlo in quella visita fatta alla Collegiata di Besozzo, vi trovò in uso il rito romano, perché anticamente era officiata dai monaci, che fino dal 1296 dipendevano dal monastero di S. Giulio di Dolzago [NdT: Dulzago] nel Novarese, e ch’egli v’introdusse il rito ambrosiano. — Né dee omettersi che in onore di questo Santo vi ha pure un Inno, solito a cantarsi nel giorno della sua festa, d’ignoto autore. Si trova pubblicato nella Novena in onore di S. Nicone Besozzi, religioso, sacerdote, anacoreta, titolare della veneranda confraternita dell’insigne borgo di Besozzo, dove si venera il suo corpo, data alla luce da Giov. Francesco Velzi, Milano, [NdT: nella stampa di Carlo Ghislandi] 1759.
- Autore:
- [Vincenzo De Vit]
- A Cura di:
- [Luciano Besozzi]
La scheda che stai visualizzando è visibile GRATUITAMENTE.
Magazzeno Storico Verbanese
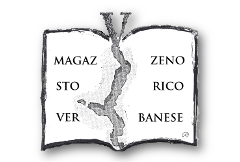 A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.
A tutti gli amici e studiosi
che nel tempo avete condiviso o vi siete interessati alle attività della Associazione Magazzeno Storico
Verbanese, dobbiamo purtroppo comunicare che in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Pisoni,
la Associazione stessa, di cui Alessandro era fondatore e anima, non è più in grado di proseguire nella
sua missione e pertanto termina la sua attività.Biografia Carlo Alessandro Pisoni
Carlo Alessandro Pisoni (Luino, 1962 - Varese, 2021). Seguendo le orme del padre Pier Giacomo, dal 1991 al 2017 è stato conservatore, per gentile concessione dei principi Borromeo, dell'Archivio Borromeo dell'Isola Bella. Appassionato studioso e ricercatore, ha sempre voluto mettere a disposizione degli altri conoscenze e scoperte, togliendo la polvere dai fatti che riguardano Lago Maggiore e dintorni; insieme a studiosi e amici, ha riportato alla luce tradizioni, eventi e personaggi passati dal lago, condividendoli con la sua gente.
